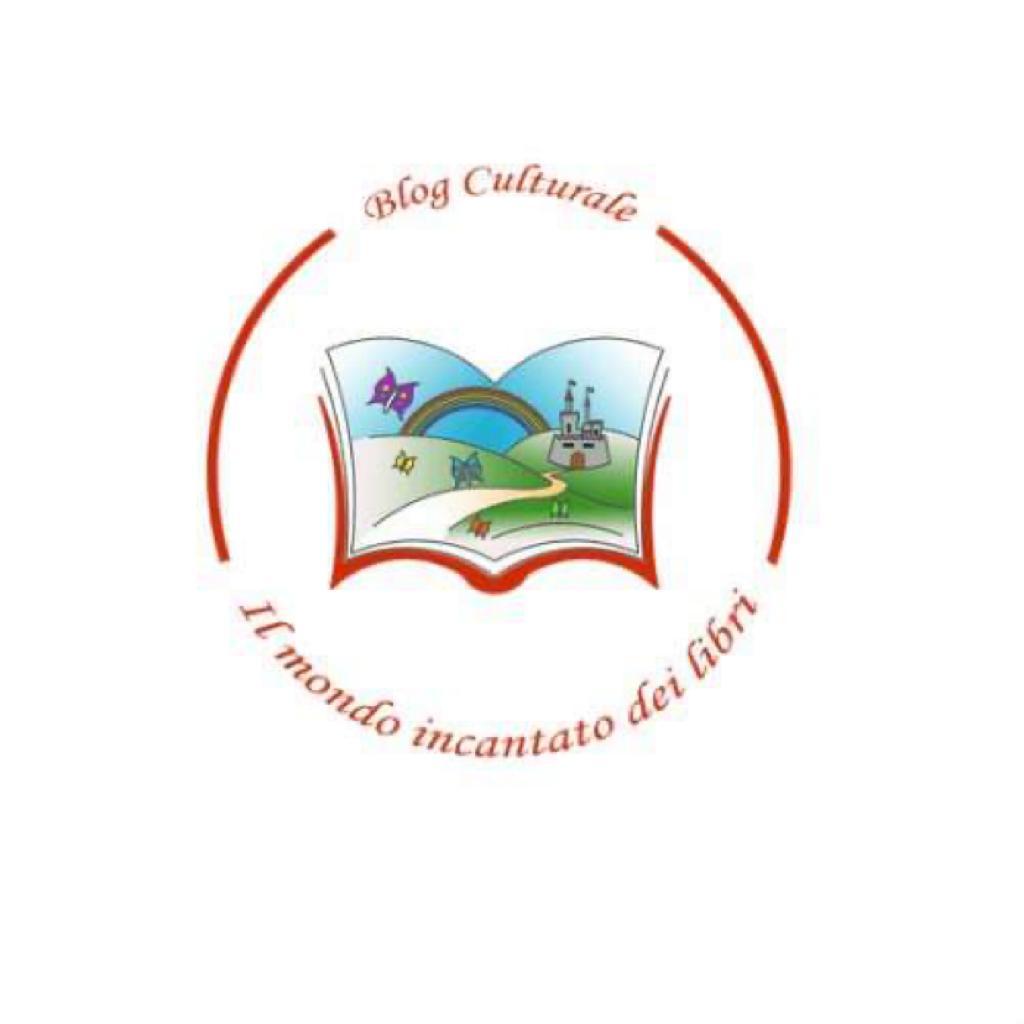“I colori del limbo” di Chiara Minutillo
Era un poeta, un artista sublime. Non sapeva giocare con le parole, ma con i colori sì. Era un maestro di luci e ombre. Sapeva vedere oltre ciò che appariva, prevedere il momento giusto in cui riportare su tela la fonte del suo interesse, quando le sfumature del giorno si sarebbero sposate meglio con le superfici che avrebbe riprodotto o quando l’età avrebbe reso una donna più bella e affascinante.
Era un uomo di umili origini, eppure sapeva tutto questo. Il suo grande dono era rendere immortale ciò che poteva deperire o sparire da un momento all’altro, come i riflessi del sole sulle acque del fiume, poco prima del tramonto.
Ogni cosa, anche la più grigia e spenta, cominciava a vivere nell’esatto momento in cui attraversava i suoi occhi. La vita dei suoi soggetti sembrava prolungarsi nel tempo, estendersi come i rami di un albero nel cielo più azzurro. Ogni cosa trovava la propria linfa vitale nel suo sguardo, nella sua fantasia. Ogni dipinto era una sua creatura, un figlio messo al mondo con dolore e sofferenza. Era la sua gioia.
Poi, l’angoscia prese il sopravvento sull’allegria. Daniel era morto e io non lo sapevo.

Ho appeso un fazzoletto bianco, candido come la sua pelle.
L’ho lasciato oscillare nel vento, sospeso sul vuoto. Lo guardavo con il timore che volasse via e mi abbandonasse, come aveva fatto lei. O, forse, stavo solo pensando di toglierlo, tastarne ancora la morbidezza, prima di avvolgerlo nella sua mano.
La sua purezza era in netto contrasto con il richiamo che esercitava. Neri avvoltoi l’avrebbero visto svolazzare, ne sarebbero stati attratti come bambini davanti ai dolciumi. Non avrebbero saputo resistere.
L’ho guardato ancora e ancora, fino a non vedere altro che quel pezzo di stoffa dondolante fuori dalla finestra. Improvvisamente mi sono alzato. Non avrei permesso a nessuno di toccarla, di profanare il suo corpo, con le mani sporche di altri cadaveri.
Ho preso un barattolo di vetro, dentro al quale io e Mary conservavamo i pochi spiccioli che ci avanzavano ogni mese. Ho afferrato ogni moneta avidamente, come un oppiomane, e mi sono precipitato in strada. Sono corso all’angolo della via, bussando alla porta chiusa del falegname. Gli ho mostrato le monete, l’ho pregato di accettare quel compenso in cambio di una bara. Non mi serviva legno pregiato o levigato, non potevo permettermelo, ma non volevo nemmeno che la mia Mary fosse trattata come una morta qualunque.
Forse ha avuto compassione di me o, forse, aveva tanti figli da sfamare e poco lavoro. Non importa il perché. Ciò che conta è che accettò. Gli ho dato quasi tutti i soldi che mi erano rimasti. Sapevo che, in quel modo, probabilmente, avrei digiunato per giorni e sarei finito a vivere su un marciapiede, come tanti vagabondi a cui la vita aveva strappato ogni cosa. Ma a cosa mi giovava avere del cibo o un appartamento, anche se modesto, se non avevo più nessuno con cui condividerlo?
Avevo sollevato il suo corpo con delicatezza, temendo di farle male.
Era magra, un uccellino appena uscito dall’uovo. L’avevo adagiata in quello che, da quel momento in poi, sarebbe stato il luogo del suo riposo. Le avevo sistemato le mani sul ventre, pettinato i capelli. Le avevo pulito il rivolo di sangue secco che le usciva dalla bocca chiusa. Poi l’avevo fissata, come se, solo perché lo desideravo, sarebbe potuta tornare in vita da un momento all’altro.
Ovviamente non era successo e, quando i necrofori si sono avveduti del fazzoletto bianco ancora appeso alla finestra, si sono arrampicati su per le scale, bussando rapidamente alla porta, impazienti di raccogliere l’ennesima preda di quella strage. Era la prima volta che li vedevo da vicino e mi sono accorto che la loro brama di cadaveri da prendere e seppellire non era dettata dalla morbosità. Prima liberavano la città da tutti quei ricettacoli di epidemie e più si sarebbero tranquillizzati.
Sono entrati nell’appartamento, osservando ogni cosa e interrogandomi con lo sguardo. Ho indicato loro l’unica altra stanza della casa, dove, vicino al pagliericcio in cui dormivamo, c’era la bara di mia moglie. I becchini mi hanno guardato, facendo un cenno di diniego. Potevano prendere solo il corpo. Ho detto che non era possibile, ho urlato e sbraitato, ma non è servito a nulla. Non si sono fatti piegare. Non sono riuscito a grattare i calli del loro animo. Allora, ho infilato la mano in tasca, estraendone le ultime monete rimaste, quelle che avevo negato al falegname e alla sua famiglia per poter sopravvivere io.
Non erano molte, ma sono state sufficienti a giungere a un accordo: una buca al cimitero, solo per lei, se io avessi trovato il modo di trasportare fino a lì la sua bara. Se ne sono andati con i soldi che tintinnavano nei loro pantaloni.
Non ho dubbi.
Il momento più doloroso non è stato quando mi sono reso conto che in lei non c’era più il respiro della vita. L’attimo più straziante è stato quando il falegname ha inchiodato l’ultima asse, nascondendo il suo viso alla mia vista. È stato in quell’istante che mi sono davvero reso conto che Mary non c’era più. Mi sono disperato all’idea che quella sera sarei andato a letto senza averla accanto. Mi sono angosciato credendo che, chiusa in quella bara, dovesse sentirsi soffocare. Mi sono arrabbiato pensando che quattro assi non avrebbero preservato il suo corpo.
Ho accarezzato la bara chiusa, dolcemente, desiderando di sentire sotto le mie dita la pelle morbida e vellutata di mia moglie. Invece, ho percepito solo la ruvidezza del legno grezzo, pieno di schegge. In silenzio, le ho giurato che avrebbe avuto una degna sepoltura.
Mi sono infilato la giacca, dirigendomi alla solita locanda, quella dove le nostre strade si erano incrociate. L’odore delle bevande alcoliche e del tabacco mi ha avvinghiato. Sono stato tentato di cedere, ma, privo di soldi e di speranze, ho ricordato subito il motivo per cui mi trovavo lì. Mi sono avvicinato a un tavolo, dove una decina di uomini stavano seduti a bere e giocare a carte. Vedendomi, si sono zittiti. La notizia aveva già fatto il giro delle strade, arrivando fino a lì. Ho letto la pietà nei loro occhi sconsolati.
Ho chiesto a quattro di loro, i più forti, di aiutarmi a trasportare la bara fino al cimitero.
Li ho implorati con la voce e con lo sguardo, fino a che sono capitolati. Non c’era solo la fatica, ma anche la paura della malattia. Ho fatto promesse che, con tutta probabilità, non potrò mai mantenere. Erano artisti come me. Vivevano di sogni e di speranze infrante. In cuor loro, sapevano che non avrei adempiuto all’impegno preso. Quel dì ci credevano e poi, qualche ora dopo, la loro certezza avrebbe cominciato a scemare, fino a scomparire. Si sarebbero gettati in altri progetti, in altre idee, in altri miraggi.
Abbiamo trasportato la bara di mia moglie per le vie della città, sudando come dannati all’inferno. Eppure, il suo corpo immerso in quelle assi sembrava la cosa più leggera al mondo. Leggera come la sua vita, che in un attimo era stata soffiata via.

Hai visto ancora un uomo che sviene, un uomo che piange?
Io mi sentii mancare varie volte, mentre versavo lacrime come un bambino a cui la madre nega l’affetto. Abbiamo percorso un lungo viale, delimitato da alberi alti, maestosi. Persino una pianta vive più a lungo di noi esseri umani. Il fetore della morte ci soggiogava. Abbiamo compiuto quell’ultimo immane sforzo, fino alla buca scavata dai becchini per Mary. Vi abbiamo adagiato la bara, dolcemente.
I miei amici mi hanno lasciato solo, rispettando il mio dolore. Ho sentito il rumore dei ciottoli pestati dalle loro scarpe, mentre si allontanavano. Quando se ne sono andati, è rimasto solo il tubare di qualche colombo e io, infine, mi sono reso conto di essere morto quello stesso giorno.
Ricordo ancora quando entrai per la prima volta nel suo studio, accompagnata da lui. Mi precedeva di un solo passo. Lo seguivo da vicino, cercando di aggrapparmi a quell’uomo che non conoscevo.
Rammento il forte odore delle tinte a olio. Lo sentii ancora prima di varcare la soglia della stanza. Iniziai a percepirlo salendo i gradini scricchiolanti della scala. Mi fece immaginare il tesoro che avrei trovato in quella camera. Spalancando la porta, Daniel mi fece entrare, forse per la prima volta, nel suo mondo. C’era un infinità di quadri appesi a ogni parete. Erano impregnati di colori profondi e penetranti. La maggior parte trasudava malinconia.
Sempre preceduta da lui, mi avvicinai a ciascun dipinto, osservandone i dettagli, quelle proporzioni perfette, i tratti delicati. Eppure, ogni pennellata che vedevo mi trasmetteva rabbia, dolore, impotenza. Trattenni le lacrime, mentre continuai a guardare in silenzio, ascoltando le sue parole.
Spiegava la genesi di ogni opera, con la fatica di chi non è abituato a usare le parole.
Nonostante ciò, nei suoi disegni c’era tutta la poesia di una composizione in versi. Daniel aveva un animo nobile, che solo pochi sono stati in grado di comprendere e ammirare. Mi mostrò ogni suo lavoro, senza orgoglio, con una sorta di pallida rassegnazione. Fu allora che capii davvero lo scopo di quell’esposizione, solo per me. Era il suo modo per comunicarmi un disagio, un problema.
Ci eravamo avvicinati a un gruppo di quadri posati a terra, coperti da un lenzuolo. Allungai la mano per scoprirli; Daniel non me lo impedì. Trovai un mondo diverso da quello che tappezzava le pareti. C’erano tinte forti, vivaci. Questo era il Daniel che avevo conosciuto e che non riuscivo più a trovare. Ricoprii nuovamente i dipinti e mi girai a guardare la tela sul cavalletto.
Era poco più di una bozza, fatta a carboncino. La donna che vi era rappresentata sembrava vera. Gli occhi scuri, dalle ciglia lunghe, catalizzavano lo sguardo di Daniel. A nessuno dei due servì parlare. Sapevo esattamente chi era quella ragazza e perché Daniel non ne avesse portato a termine il ritratto. Eppure, lei era ancora lì, al centro di quella stanza. Era stata la musa di Daniel, la sua fonte d’ispirazione. Ora era la causa della sua apatia.
Aveva tanti nuovi progetti iniziati: dipinti commissionati, alcuni già pagati, ma nessuno terminato. Daniel viveva in una sorta di limbo, da quando lei se ne era andata. La tela incompiuta che sostava sul cavalletto era l’ultimo ricordo che aveva della donna che amava. Si erano conosciuti in una locanda, una delle tante che gli artisti come Daniel frequentavano. La lettera che mi scrisse allora, quando mi comunicò di essersi innamorato di una cameriera, invece di ferirmi, mi tranquillizzò. Era la sua vita. Aveva diritto di fare ciò che lo rendeva felice.
Non scrisse più, per dieci lunghi anni, e qualsiasi cosa io gli spedissi rimaneva senza risposta.
Fino a quella seconda lettera. Mary non c’era più. Leggendola, mi resi conto che Daniel era un poeta anche quando scriveva. La tisi si era portata via la sua Mary e da mesi lui viveva nella disperazione. Accettava qualsiasi lavoro, ma ogni quadro che iniziava a dipingere gli ricordava lei. Il suo amore era diventato una tortura, una lenta agonia. Mi misi subito in viaggio, temendo di perderlo.
Era magro, consumato lentamente, come una roccia scavata da minuscole, insistenti gocce di acqua. Fu solo vedendolo che mi resi conto davvero di quanto l’amore potesse far male.
Quel giorno, dopo avermi mostrato ogni suo dipinto, mi parlò a lungo della morte. Non voleva lasciare questo mondo. Voleva spogliarsi di tutto, rinnovarsi, come fa un serpente con la pelle che non gli serve più.
“La morte è liberazione”, mi disse.
Lo guardai perplessa, ricordando perfettamente i pensieri che mi avevano attraversato la mente quando avevo letto quella frase.

“Ritratto di donna con fiori”, carboncino di Etienne Adolphe Piot
Sono passati mesi e non so cosa provo.
Non sento dolore né rabbia né disperazione. Sono inerte, passivo. Nulla mi dà gioia. Non ho più idee, i miei occhi non vedono più. Vivo nel buio, in una tenebra profonda. La morte è liberazione. Per ora, l’unica cosa di cui mi sono liberato sono i sentimenti. Non credo che questo possa giovarmi, ma, del resto, se anche ne traessi beneficio, non potrei rallegrarmene. La gioia stessa è un’emozione, qualcosa che non mi è più concesso.
Vivo trascinandomi, come un verme. A volte ho ricordi vividi e intensi, che spesso si riempiono di polvere. Allora, mi sforzo di ripulirli, per conservarne la purezza e la bellezza. Nelle mie memorie, Mary vive sempre. Il suo sorriso, disegnato sulle labbra rosse, perseguita i miei sogni. La verità è che non riesco a raggiungerla. Lei vive ancora da qualche parte, ma non so come toccarla, come parlarle.
È come stare fuori da un appartamento, vederne l’interno attraverso le finestre, osservare Mary e non avere la chiave per aprire la porta e raggiungerla. La chiamo, ma non mi sente. Apparteniamo a due mondi diversi, che non possono congiungersi.
Non riesco più a dipingere, i colori si confondono. Ogni volta che provo a prendere in mano i pennelli, creo dei mostri. Quadri lugubri, tetri, dalle tinte spente. Eppure, nelle rare occasioni in cui concludo qualcosa, tutti mi lodano per il mio lavoro. Forse, sono io a vedere la bestia dove non c’è.
Ogni giorno che passa, sento che i miei ricordi si affievoliscono.
Ho paura di scordare il suo viso, la sua voce. A volte mi arrabbio con lei, per avermi lasciato solo, a soffrire come un cucciolo abbandonato. E allora riesco a sentire la sua risata. Sembra che si prenda gioco di me. Sono quelli i momenti in cui cerco di raggiungerla.
Mi rimetto fuori dall’appartamento che porta i segni della nostra vita insieme, e guardo da una finestra. Vedo la polvere depositarsi rapida e meschina sul vetro. La soffio via continuamente, ma lei torna sempre, come se non avesse altro posto in cui andare. E io mi sono stancato di pulire in continuazione ciò che, ormai, è stato sporcato per sempre.
C’è stato un periodo in cui ho pensato che tornare a comporre quadri fosse la soluzione alla mia apatia.
Percorrevo le strade della città in lungo e in largo, alla ricerca di una qualsiasi cosa di cui valesse la pena catturare l’essenza per rinnovarla, trasformarla e trasfonderla a altri. Rientravo a casa, carico di aspettative. Iniziavo una quantità spropositata di tele, sulle quali trasferivo la piccola fiammella di ispirazione che mi era rimasta. Quando anche quella si estingueva, accantonavo i quadri, abbandonandoli a se stessi come orfani. A volte mi muovevo a compassione, le rimettevo sul cavalletto e le terminavo, per poi rendermi conto che non erano mai come le avevo desiderate e immaginate. Vi trasferivo i miei pensieri e le emozioni, quelle cose che non riuscivo più a sentire davvero, a identificare nella mia piccola, miserabile vita.
Ho cominciato in quel momento a prendere atto di quello che il mio cuore comunicava. Guardavo le mie creature e comprendevo che rabbia, frustrazione e impotenza erano tutt’altro che sparite. Invece che la soluzione, l’arte è divenuta la mia valvola di sfogo.
Era Mary a darmi forza, a incoraggiarmi. Era lei a ispirarmi. Era lei a farmi vedere la bellezza di un cielo grigio, di una strada piena di prostitute e miseria, di un bambino affamato a piedi nudi. Era lei a trasformare i colori nella mia mente.
Il ricordo del suo viso aveva cominciato a svanire, evanescente come il dono di vedere oltre ciò che era tangibile e visibile a tutti. Non avevo pace. Mi tormentavo in continuazione, struggendomi per conservare la memoria dei suoi tratti delicati, del velluto dei suoi capelli, dei suoi occhi ambrati. Dentro mi sentivo prigioniero, incatenato in un limbo da cui ero costretto a guardarmi attorno, senza trovare una via d’uscita. Ero intrappolato in un luogo dove scontare una pena infinita, in attesa di un paradiso a cui non credevo più, mentre, fisicamente, ero come martoriato dalle fiamme dell’inferno.
Per farmi coraggio, mi sforzavo di immaginare l’Eden, il turchese delle cascate, il verde brillante dei prati.
Cercavo di crederci, ma, ogni volta, i colori e le forme venivano coperti e sostituiti da veli infiniti di polvere e allora comprendevo che il vero paradiso era lì, dentro quell’appartamento dove ogni notte scorgevo Mary. Avevo bisogno di trovare la chiave per entrare nuovamente nella sua vita.
Mi sono seduto davanti a una tela nuova, immacolata, come il fazzoletto che mesi prima avevo appeso alla finestra per richiamare i becchini. Ho lasciato da parte colori e pennelli. Volevo realizzare qualcosa in bianco e nero, come mi sentivo io. Presi un semplice carboncino e iniziai a ritrarla, così come la ricordavo e come appariva nei miei sogni.
Infine, Daniel aveva trovato la chiave di accesso ai suoi ricordi con Mary. Il ritratto incompiuto colpiva per il doloroso tormento che si scorgeva nei suoi tratti. Osservai Daniel prendere posto davanti al cavalletto. Era afflitto, inseguito da ricordi sfumati che non gli davano tregua, perseguitato dall’indecisione e dall’incapacità di liberarsi dalle proprie catene.
Era stanco di spiare da una finestra impolverata.
Voleva entrare in quella casa, in quella vita, in quelle memorie, ridando loro il colore che avevano perso. C’era quasi riuscito quando aveva iniziato a ritrarre la sua adorata Mary, salvo poi accorgersi che, aprendo quella porta, lei ne sarebbe uscita, andandosene definitivamente.
Per riavere ciò che gli apparteneva, Daniel doveva trovare il coraggio di lasciare andare Mary. Non era ancora disposto a farlo, ma sapevo che, prima o poi, si sarebbe deciso. Con molta fatica e dolore, sarebbe stato in grado di recidere quel cordone che teneva Mary ancorata a lui, prigioniera di una vita che non le apparteneva più.
Lo strinsi forte a me, sussurrandogli parole di conforto all’orecchio. Poi tacqui, indecisa su cosa dire per fargli capire che gli ero vicina, che non l’avrei abbandonato, nonostante i dieci anni passati lontani uno dall’altra. Dieci anni che ci avevano resi estranei.
”Ti voglio bene, figlio mio”, fu tutto ciò che riuscii a dire.