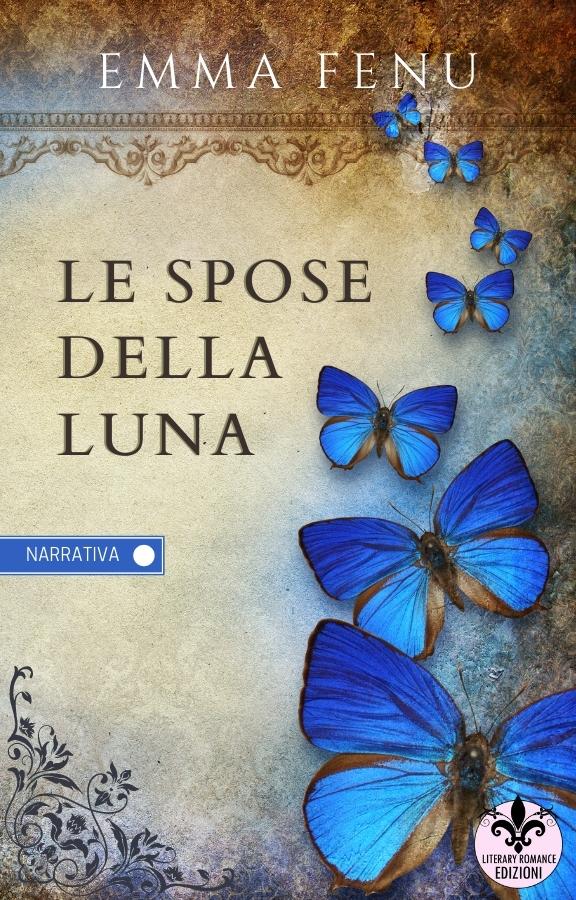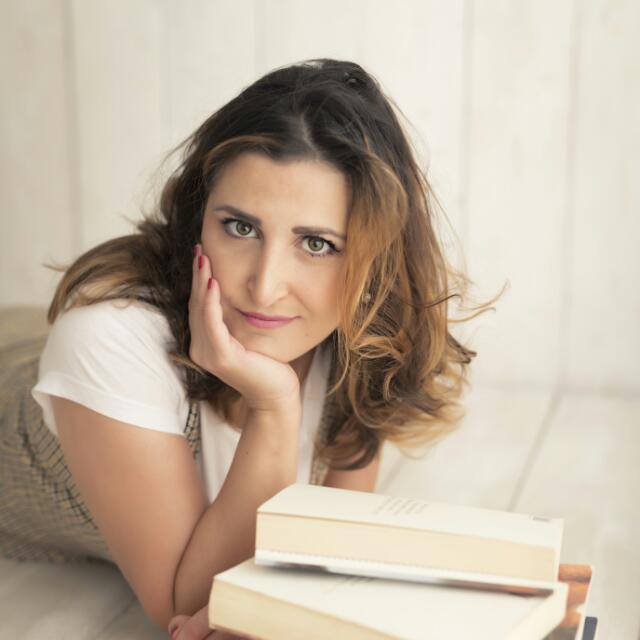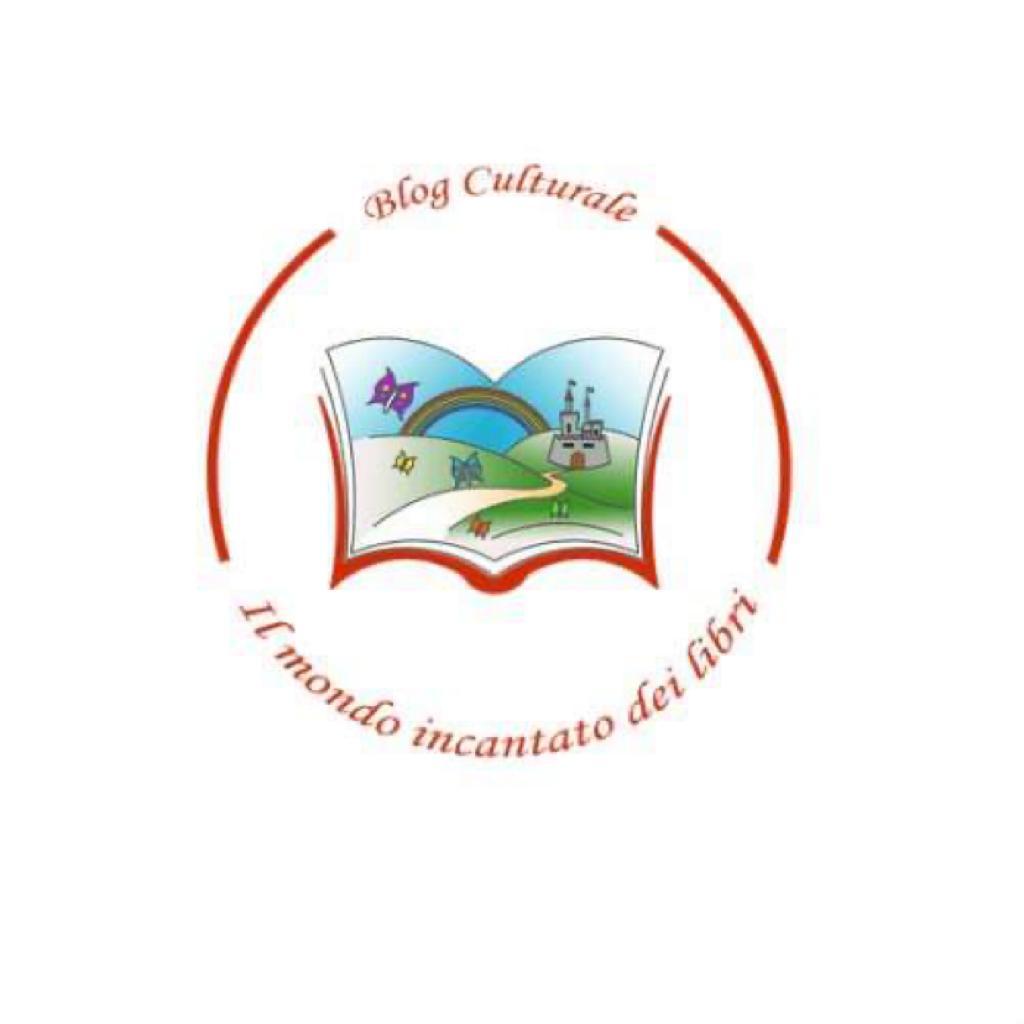L’epoca storica di Emily Brontë
a cura di Anna Ferriero
Emily Brontë è conosciuta universalmentevsoprattutto grazie al capolavoro Cime Tempestose.
“Perché la passione che brucia, non si spegne di fronte a niente, neanche di fronte alla morte” – Nelly
Dean
Una storia d’amore. Un pensiero proibito. Un sentimento peccaminoso. Un sogno innocente. Una speranza istintiva che sa travolgere il cuore con delicatezza estrema al punto da rapirlo.
Rapirlo per sempre, per donarlo, senza vita, durante un giorno d’inverno pungente, quando il nitrito del cavallo del Signor Lockwood, Albert Lokwood, perdendosi nella brughiera, fa rivivere, all’interno di quell’unica ed isolata casa illuminata, quella storia: a tratti gotica, a tratti romantica, a tratti sempliciotta, a tratti spaventosa e pura, in un’atmosfera macabra, abitata da fantasmi viventi nell’urlo del vento, illuminata dai fulmini partoriti dai temporali, rievocata dai passi ansiosi e svelti prodotti dal battito dagli stivaletti in pelle.
Un passato che dev’essere obliato ma che chiede di essere rivissuto un’altra ed infinita volta. Per l’ultima eterna volta.
Per un altro istante. Per un altro anno. Per un’altra interminabile ora.
Anche se, nonostante il trascorso debbaessere sotterrato, è quasi impossibile fra gli scricchiolii delle porte in legno di rovere impiallacciato. Perché?
Perché impediscono che il mondo dei vivi ed il mondo dei morti resti separato, soprattutto in un luogo come Cime tempestose.
Ogni oggetto circoscritto nella brughiera di Heathcliff, come ogni spazio, sembrava assumere un aspetto animato; sembrava racchiudere, nelle viscere di quella Terra, quel grido silenzioso edinquieto che, eccessivamente prematuro, era stato strappato dall’elemento pulsante che, ancora oggi, si narra, palpiti ininterrottamente: LA LIBERTÀ DI AMARE.
Una storia che non ebbe successo immediato: considerata non convenzionale ed immorale. Forse perché reale? Forse perché attraverso di essa, Emily, voleva evadere dalla mentalità della sua gente?
O forse perché, l’anima di una donna, non può vivere sottomessa alle rigide regole della femminilità, regole che col tempo, potrebbero trasformarsi in una vera e propria condanna, a tal punto, da desiderare la morte per la liberazione.
Heathcliff: “È qui! È lei! Dopo tanto tempo: lo sapevo! È la sua voce! È tornata!”
Albert Lokwood: “È solo la voce del vento. È il vento, Signor Heathcliff… ”
Non a caso, il nome della protagonista Catherine, significa ciò che è puro, genuino. Questa scelta non è assolutamente un caso. Infatti, i suoi tratti nascosti si possono notare attraverso più momenti: all’inizio Cathy è descritta come una bambina con poche amicizie, bella ma semplice, intelligente e a tratti viziata; successivamente diventerà una ragazza molto legata ad Heathcliff (luogo dello Yorkshire in perenne tempesta.
Infatti, egli, è un ragazzo ribelle, oscuro, selvaggio. Addirittura viene descritto come la reincarnazione del demonio); per poi sposare Linton, per salvare, in un certo senso, la vita di Heathcliff.
Questo non è uno scritto, neanche un romanzo, neppure una storia d’amore, nemmeno un racconto reale o un poema: è un incontro di destini che si concretizza. Ecco.
Emily Brontë pone il lettore direttamente nella tangibilità vitale. La scrittrice vittoriana, attraverso la sua delicatezza, intelligenza ed istruzione catapulta il lettore nel bel mezzo della tempesta, senza troppi giri di parole, preamboli, precauzioni, senza prepararlo o metterlo in guardia, perché la Brontë (cognome ribattezzato da un reverendo inglese perché, per suo avviso, contenete una nota di romanticismo in più), è una donna diretta.
Un cognome letteralmente scelto ma non del tutto, poi, chiaramente compreso. Perché se da un lato sarebbe stato scelto per aggiungere una nota di romanticismo in più, dall’altro, molto probabilmente, voleva camuffare le origini familiari umili o forse, ancora, desiderava far riecheggiare il recontico (come giusto che fosse da uomo di chiesa quale lui era).
Infatti, la parola greca tempesta, rimandava a qualcosa di movimentato, agitato, superiore. Molti, più semplicemente, d’altro canto, ricollegano la scelta del cognome all’ammiraglio Nelson, nominato duca di Bronte nel 1799.
Il suo primo, meraviglioso ed unico romanzo non ha bisogno di nulla, semplicemente dell’animo coraggioso che ha curiosità di imbattersi nel rigido inverno dello Yorkshire, promettendo però, di non ritornare indietro a metà strada.
Pur non leggendolo fra le righe d’inchiostro, Cime tempestose è, come appieno, un romanzo autobiografico.
E, se consideriamo la storia della vita della Brontë, forse dei piccoli elementi e dei leggeri tratti sottoforma di allegorie, li ritroviamo, quasi con ritmo incalzante.
Breve biografia di Emily Brontë
La primissima pagina del romanzo con copertina nera, edito da Oscar Mondadori, tradotto da Margherita Giacobino, intitolata La magnanimità di Cime tempestose contiene testuali parole:
“C’era una volta, si dice, un reverendo inglese, di nome Brunty o Branty ribattezzatosi più romanticamente Brontë, che portò, verso casa, ai suoi quattro bambini, una scatola con dodici soldatini di legno. I bambini Vivevano isolati in una canonica nelle brughiere dello Yorkshire, ovvero: AI CONFINI DEL MONDO”.
Da qui parte una descrizione molto esaustiva della psicologia dei bambini, attraverso la quale già è possibile reperire il motivo della nascita di Cime tempestose.
Dunque, Emily era la seconda figlia del reverendo inglese (prima di Anne e dopo Charlotte). Le fonti attestano anche dell’esistenza di un fratello, l’unico fratello Brontë, Patrick Branwell. Anche egli un artista, un pittore molto talentuoso ma morto alla sola età di 31 anni a causa dell’alcol e dell’utilizzo sfrenato di oppio (una sorta di suicidio).
Patrick Branwell rappresenta un po’ il creatore della morte della famiglia artistica Brontë; infatti, dopo di lui, tutti moriranno, uno dietro l’altro a distanza di pochissimo tempo.
La prima a seguirlo fu proprio Emily, morta a 30 anni per una tristezza che iniziò a divenire cronica, seguita poi, dalla tubercolosi. A precederla, fu la
sorella maggiore Anne, morta all’età di 29 anni. L’unica Brontë che riuscì a vivere un percorso più lungo fu Charlotte, prelevata dalla morte all’età di 39 anni conseguentemente al parto.
Già dopo la morte di Maria ed Elizabeth, il peso e la responsabilità di essere la sorella maggiore ricadde proprio sulle fragili spalle di Charlotte: una sorella, un’amica, una madre.
Gli aggettivi che descrivono il carattere di Charlotte? Geniale, testarda, intelligente, forte, sfrontata, intuitiva, matura, talentuosa. Ed è proprio il talento, l’elemento magico, ad unire e ad accomunare le tre sorelle vittoriane.
Un’inclinazione letteraria da essere nutrita, alimentata, curata, amata, ammirata, mostrata al Mondo; ma un dono, questo, da proteggere e rivendicare. Ma perché?
L’ETÀ VITTORIANA
Ponte tra Romanticismo etico e modernismo
Si conosce l’Inghilterra per le bellezze e le meraviglie delle due regine più importanti: Elisabetta I ed Elisabetta II, quindi il Regno elisabettiano; ma, spesso e quasi involontariamente (perché a noi lettori tutto si svolge in maniera totalmente automatica), ricordiamo l’età Elisabettiana (Shakespeare per esempio), ricollegando il periodo a quello precedente: l’Età Vittoriana.
Dunque, quando ricordiamo l’età vittoriana, anche senza averla studiata e / o approfondita, rammentiamo immediatamente alla figura del piccolo Oliver Twist di Dickens, oppure a Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, o, ancora ad Agatha di George Eliot (pseudonimo diMary Anne Evans).
Tutte queste opere hanno in comune un’età, un’era, all’interno della quale, l’Inghilterra fu divisa in due blocchi: l’Inghilterra ricchissima e l’Inghilterra poverissima.
E fu proprio durante il Regno della Regina Vittoria che gli inglesi si resero lentamente conto di avere un impero, il quale, esattamente come le scuole, le fabbriche e la sanità pubblica, richiedeva un crescente impegno di amministrazione e di improvement.
Ma, nonostante ciò, durante l’epoca vittoriana, una donna che si dedicasse alla scrittura e alla letteratura non era di certo ben vista. Cosi, le sorelle Brontë, di comune accordo, decisero di adottare uno pseudonimo che le proteggesse (conservando però, le iniziali dei loro nomi e cognomi), nonostante questa vittoriana fu un’epoca di grande fermento creativo e di innovazione soprattutto letteraria.
Hanno successo, in questo periodo, le short story o il racconto breve. Non più sotto la protezione di aristocratici tanto influenti quanto illuminati, l’intellettuale, ora, per scrivere, deve adattarsi ai gusti mutevoli del grande pubblico; la sua sopravvivenza dipende più dal numero di copie vendute che dal pregio intrinseco dell’opera.
Questo porterà ad una paura da parte degli editori, i quali, molto restii, inizieranno a pubblicare le opere pezzo per pezzo, fascicoli settimanali o quindicinali senza sicurezza.
Le sorelle Brontë, un trio di scrittrici famose per aver pubblicato tre romanzi nello stesso anno, 1847, decisero, di comune accordo, di firmare le loro opere con uno pseudonimo a causa dei pregiudizi, che allora, andavano formarsi forti, nei confronti delle donne.
Durante l’età vittoriana, la donna era una sorta di oggetto intoccabile e femminile, quindi, tutto ciò che potesse allontanarla dal femminile era indice di vergogna (un po’ come se fosse stata una malattia). Il ruolo delle donne si riduceva a procreare e ad occuparsi della casa, in casi rarissimi, poteva limitarsi all’educazione dei figli. Si arrivava addirittura a dire che studiare fosse contro la loro natura e che potesse farle impazzire con un tempo.
Le uniche professioni accessibili erano quelle dell’insegnante o della domestica. Il corpo della donna era visto come un elemento puro e pulito, da escludere il periodo mestruale, durante il quale, la donna, era considerata malata e quasi immonda.
Per una donna rispettabile non era consigliato portare alcun genere di trucco o altri ornamenti, né indossare vestiti che mostrassero il corpo o, ancor più scandaloso, l’intimo, questo perché suscitava la nascita di idee “strane” capaci di far sviluppare la mente femminile in modo da renderla curiosa e, la curiosità, era sinonimo di libertà perché collegata alla creatività.
Ricordiamo, ad esempio, uno degli episodi più eclatanti della Regina Vittoria, e cioè, quando Alberto fu notato, per il suo vestiario, proprio dall’occhio di Vittoria. si legge alla pagina 31 della storia della regina Vittoria di Richard Newbury:
“Alberto è così affascinante e così incredibilmente bello: stupendi occhi azzurri, un naso squisito ed una bocca proprio carina… Ha un corpo perfetto. Aderenti pantaloni di cachemire, senza niente sotto, e alti stivali”.
Il corpo come la psiche femminile era talmente bello a tal punto da far paura, ragion per la quale, ogni elemento, anche il più piccolo, poteva metterlo in risalto e divenire elemento di desiderio da parte del sesso maschile
. Questo limite, ovviamente, non era assolutamente valido per gli uomini, i quali, godevano di una libertà quasi sproporzionata. Si può comprendere ciò nella lettura sulla vita della regina Vittoria quando, a metà pagina 23 si narra del nascente legame fra la regina ed il suo primo ministro di 50 anni più giovane, Whig Lord Melbourn:
“Figlio di un altro uomo rispetto ai suoi fratelli; Giorgio IV incluso. La stessa madre aveva aiutato Byron a sfuggire Lady Caroline facendosi sposare la propria nipote ed erede. Il primo ministro si era fatto consolare da almeno altre due donne”.
Nell’era vittoriana era molto difficile costruirsi una buona reputazione, al contrario, era molto facile perderla. Era naturale per un uomo aver bisogno femminile, ragion per la quale, senza ombra di dubbio, prostituirsi era considerato atto di isolamento da ogni elemento a partire dalla famiglia.
Una donna che si prostituiva era una donna, alla quale, era stata imposta una punizione grave e, dalla quale, non poteva più liberarsene o, se avesse avuto la possibilità di farlo, sarebbe rimasta disonorata a vita. Picchiare una donna era quasi cosa doverosa, la si considerava una sorta di simpatia che, in questo modo, la donna era in grado di suscitare.
Dunque i temi affrontati sono tantissimi: il macabro: elemento cardine dei romanzi gotici. Perché?
Piero Bocchiaro, psicologo italiano (siciliano), all’interno del suo libro Psicologia del male scrive:
“La quasi totalità delle persone, oltre a ritenersi immune dalla possibilità di compiere azioni crudeli, si pensa al di sopra della media rispetto a molte qualità–onestà, sensibilità, generosità, per citarne alcune.
Questa tendenza, ampiamente studiata dagli psicologi, è l’esito di una manipolazione sistematica e automatica effettuata sulle informazioni riguardanti il sé. Più in dettaglio, le persone, spinte dal bisogno universale di percepirsi positivamente, […] si confrontano con chi è in condizioni peggiori, sovrastando il proprio contributo a imprese comuni, recuperando in maniera selettiva ricordi positivi.”
Dunque il nostro io, per sentirsi sicuro di sé, ha bisogno di vedere qualcuno che sta peggio: non è quindi una questione di empatia e compassione, ma più un gongolare delle disgrazie altrui per sentirci superiori.
Un “sentirsi vivi” scatenato da drammi altrui. Il gotico contiene in sé qualcosa di speciale, magico, stregato ma vero e, il lettore, senza essere avvisato, viene attratto a tal punto, da trasformarsi in un vero e proprio personaggio dell’epoca, che assiste alle scene dalle finestre, facendosi coinvolgere pienamente, subendo così, attacchi di rabbia, rancore, malinconia, solitudine, tristezza, compassione. Il gotico condivide molto con il
Romanticismo, movimento artistico – letterario ottocentesco, all’interno del quale, l’individualità, assume un’importanza fondamentale.
È perciò il singolo stesso a definire ciò che è gotico. Un aspetto che può apparire curioso della cultura goth è l’amore. Questo non significa la mancanza di storie d’amore, bensì, al contrario, forse, la consapevolezza che, con l’amore, possa esserci la delusione. Emily Brontë: una delle autrici più controverse, più ribelli e forti, interpretate e reinterpretate dalla critica, dalla storia della letteratura ma mai del tutto compresa, mai del tutto esplorata, mai del tutto categorizzata.
Emily Brontë era una donna originale, magnetica, unica, fuori dal comune, diversa, straordinaria, ricca di talento, assolutamente non convenzionale, sensibile e forte al contempo.
Una personalità intorno alla quale si è creato un vero e proprio enigma a tal punto, da rendere il lavoro difficile, tutt’ora, alla storia della letteratura. Ancora oggi, a distanza di diversi secoli, questa figura misteriosa lascia noi, nuove generazioni, indietro, indietro per cecare di interpretare cosa volesse raccontare al mondo esterno la vera essenza della natura umana primordiale, istintuale, viscerale.
Un amore per la natura profondo e mistico per alcuni versi.
Aveva sviluppato anche una vista spirituale che prendendo le distanze, per alcuni versi, da ciò che era la dimensione reale, dimensione nella quale, fondamentalmente, era nata. Elemento che, forse, l’ha portata alla malattia perché, forse, quello, era un mondo non ancora pronto per Emily.
Cime tempestose, un capolavoro che ha dovuto subire, come gli altri, un lungo ed interminabile percorso prima di poter vivere nel cuore del lettore. Questo perché Emily non apparteneva ad una famiglia nobile, affermata, benestante né possedeva amicizie facoltose che potessero, in un certo senso, aiutarla, appoggiarla, sostenerla.
Poco conosciuta, insieme alle sorelle, come poetessa, nel 1846 riuscirà a pubblicare una raccolta poetica con le sorelle dal titolo POEMS of Currer, Ellis e Acton Bell attraverso pseudonimi che saranno la loro fama e che le accompagneranno fino alla morte. Già da questo titolo si può percepire la straordinaria intelligenza delle Bell.