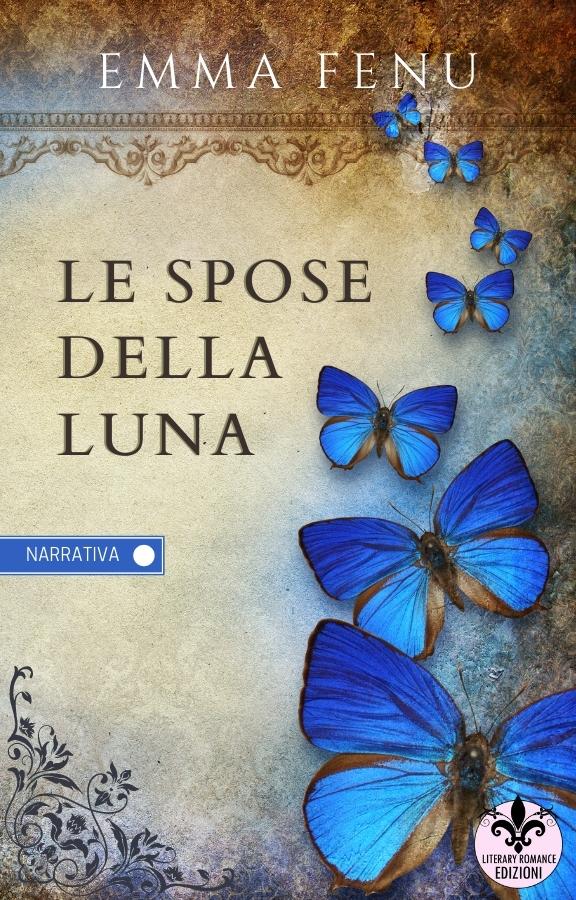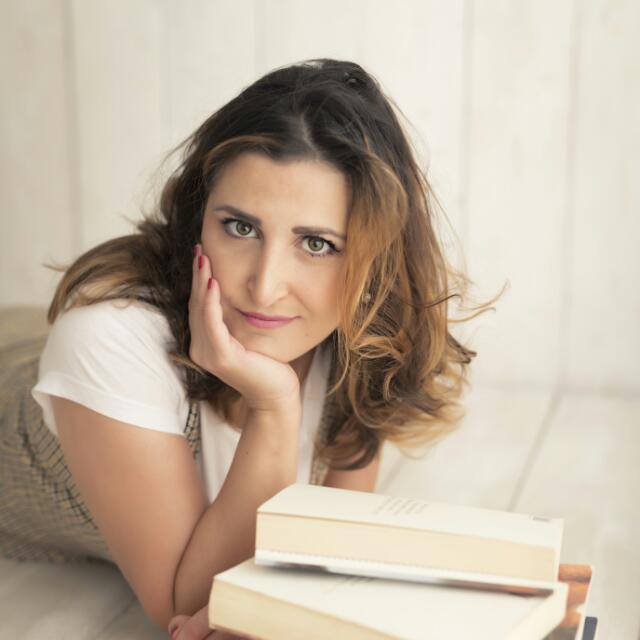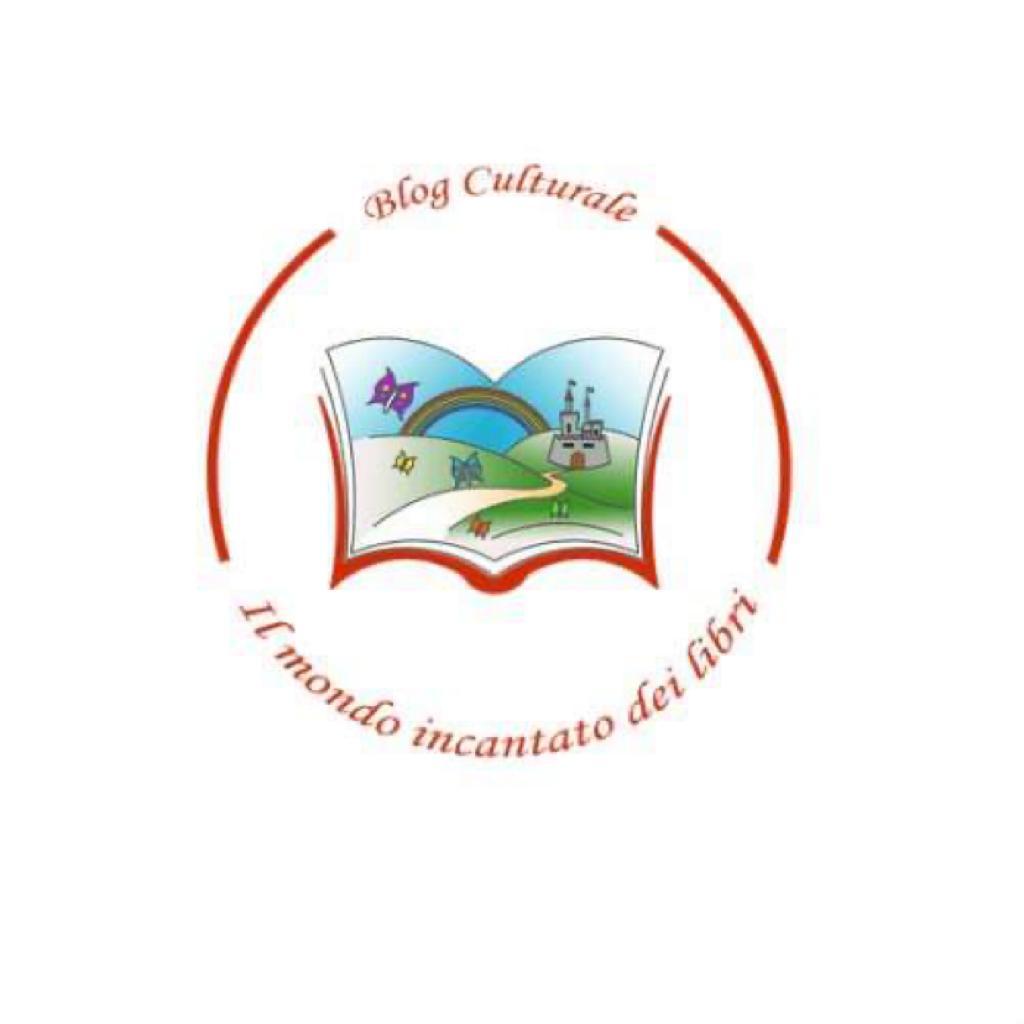“La luna e i falò” di Cesare Pavese
di Carolina Colombi

La luna e i falò è romanzo evocativo
È un’afosa serata estiva del 1950, quando Cesare Pavese, scrittore, poeta e saggista di fama già consolidata, sceglie di chiudere la sua parabola con la vita.
Soltanto pochi mesi prima ha dato alle stampe la sua ultima fatica letteraria: La luna e i falò.
Sviluppato su piani temporali diversi, La luna e i falò è romanzo evocativo.
Che grazie ai numerosi flashback di cui è costellato, porta il lettore a dividersi fra passato e presente.
Ricco di motivi autobiografici, La luna e i falò mette a confronto i due periodi più significativi dell’esistenza del protagonista.
L’adolescenza, ormai parte del passato, in contrapposizione al momento presente, quello della maturità.
Momento in cui l’uomo intraprende un viaggio alla ricerca del suo più profondo sé.
“C’è una ragione perché sono tornato in questo paese e non invece a Canelli, a Barbaresco o in Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo: dove son nato non lo so…”
Anguilla, voce narrante e protagonista del romanzo, dopo una lunga assenza, fa ritorno al suo paese d’origine.
Terminata la seconda guerra mondiale l’uomo torna lì, fra le colline delle Langhe, custodi della propria interiorità.
Lì, dove tutto ha avuto origine.
Ripercorrendo i luoghi della sua infanzia, Anguilla fa memoria dei suoi trascorsi fanciulleschi, durante la quale spera di rintracciare frammenti del proprio vissuto giovanile.
A mettere in atto il processo del ricordo è Nuto, compagno d’infanzia di Anguilla, che lo accompagna attraverso il loro comune passato.
Ed è compito di Nuto riferire all’amico gli accadimenti avvenuti nel periodo in cui lui era oltre Oceano: la ribellione contro i nazifascisti, gli orrori della guerra civile che hanno bagnato di sangue innocente le verdi e rigogliose colline piemontesi.
Eventi tragici, in seguito ai quali la vita degli abitanti di quelle incantevoli valli è cambiata.
Anguilla, che ne La luna e i falò assume sia il ruolo di narratore sia quello di personaggio principale, vorrebbe conoscere il luogo dove è nato, al fine di rintracciare la parte più recondita di sé.
Ma non gli è dato sapere il posto in cui ha visto la luce quarant’anni prima: in quanto figlio adottivo è nato presso l’ospedale di Alessandria.

Cesare Pavese è rappresentante importante della letteratura del Novecento.
Proseguendo il viaggio sui binari del ricordo, i due riprendono il filo del tempo condiviso.
Per mezzo del quale Anguilla ricorda la cascina di Gaminella, casa nella quale è cresciuto; ricorda poi la sua famiglia adottiva: i genitori, le loro figlie, con le quali ha trascorso piacevoli momenti infantili.
Famiglia, disgregatasi in seguito a episodi che un destino sciagurato ha posto in mezzo a loro.
Motivo per cui, il ragazzo di allora si è visto costretto ad andare altrove, presso un’altra fattoria: quella della Mora.
Fattosi nel frattempo giovanotto, sospettato di attività sovversiva nei confronti del fascismo, Anguilla si è trasferito a Genova, città dalla quale si è imbarcato per le Americhe.
Paese però, dove non ha trovato ciò che cercava.
Non ha ricordi felici da legare alle diverse città in cui è vissuto, e l’amore, a lungo agognato, si è rivelato essere utopia.
E adesso, tornato alla ricerca delle proprie radici, scopre una realtà diversa da quella desiderata, a causa anche dell’imminente tragedia che minaccia il paese.
Perchè Valino, padre di Cinto, altro personaggio che si accompagna ad Anguilla e a Nuto, impazzisce e dà fuoco alla Gaminella, cascina in cui vivono. E dopo questo gesto malsano s’impicca.
A questo punto, Anguilla affida Cinto a Nuto, e abbandona i luoghi su cui tanto aveva fantasticato.
“Era un’idea. Quella macchia di canne e, dietro, i pini rossastri e l’erba sotto, rigogliosa, mi ricordavano la conca in cima alla vigna di Gaminella. Ma qui c’era di bello ch’era la punta della collina e tutto finiva nel vuoto.”
Il focus che caratterizza il romanzo è la rivisitazione dei luoghi della memoria.
Ed è proprio la rivisitazione dei luoghi dove è nato e cresciuto, a essere lo scopo principale del viaggio di Anguilla.
Al fine di ritrovare la propria identità fra le Langhe piemontesi.
Ricerca che trova la sua ragione d’essere nel ritorno.
Pur avendo riscoperto il suo amato paesaggio, con odori e sapori conosciuti, gli stessi che hanno accompagnato la sua infanzia, Anguilla non rinviene però il tramite per ricongiungersi ai posti in cui poter dare pace alla propria anima.
Pervaso dalla malinconia, con il cuore colmo di sofferenza, l’uomo è consapevole che le sue aspettative sono andate deluse.
Non ha ritrovato coloro i quali sperava di incontrare, anche per manifestare il proprio stato sociale.
Adesso infatti, a differenza di quando ha lasciato il paese, Anguilla è un uomo benestante.
Il suo ritorno è quindi permeato da una sensazione di vuoto, un’amarezza di cui non aveva coscienza prima di raggiungere il suo paese.
Perché i luoghi della memoria, a lungo vagheggiati, non esistono più. Come non esistono più le persone di cui aveva ricordo.
Anche il paesaggio, che l’ha visto bambino e poi ragazzo, gli appare diverso da come lo ricordava.
Un mondo millenario che si è frantumato, e gli si palesa attraverso la trasfigurazione del ricordo stesso, che nella narrazione si fa simbolo per interpretare la realtà.
Realtà la quale si scontra con l’immagine, idealizzata nella sua fantasia, dei tempi andati.
Infine, i falò.
Quale significato attribuire ai falò? Quale è la chiave interpretativa che permette di dare un significato a questo simbolo?
Non sono più l’evento fecondo e propiziatorio che accompagnava i ritmi della campagna.
Non più la gioia di stare insieme per rendere solenni le feste di paese, accompagnate dal crepitio del fuoco a rallegrare gli abitanti delle valli.
Nulla di tutto ciò ormai fa parte del presente.
Perché la memoria del passato è andata perduta per sempre, e mutata dal significato che il fuoco assume nel contesto narrativo de La luna e i falò.
Perchè nei tragici fatti di cui Anguilla è stato testimone, vissuti durante la sua peregrinazione con Nuto, il fuoco si è rivelato essere elemento di morte, violenza e sangue.
Facendosi mezzo per soddisfare la furiosa brutalità di un uomo e distruggere la vita di una donna. Divenendo in tal modo emblema di disgrazia e di fine.
Ed è così, che unitamente al mito del ritorno e a quello del ricordo, crolla anche quello del falò.
Il mito è elemento centrale della poetica di Pavese, ed è inteso non quale forma di consolazione od oblio, ma mezzo per conoscere una realtà più vasta, che va oltre la cognizione di sé.
Ed originandosi dall’esperienza umana determina il destino dell’uomo, divenendo imprescindibile dal suo IO.
Il mito più ricorrente di tutta l’opera del poeta è quello della propria terra, concepita come luogo che induce l’espatriato al ritorno.
Quasi fosse un richiamo a sé, attraverso il mito del ritorno.
Mito anche questo deluso, purtroppo, in quanto l’incontro con il proprio luogo d’origine si risolve spesso in solitudine.
Concezione questa molto esplicativa della personalità di Pavese, che introiettato sulle proprie difficoltà comunicative ha vissuto la vita sotto il segno dell’angoscia, sottintesa poi nel cosiddetto “male di vivere”.
Attraverso la tessitura della trama, raccontata con ritmo tranquillo, si assiste a un’esposizione delle emozioni raccontate da un punto di vista soggettivo e intimista.
Ma, nella struttura narrativa de La luna e i falò non c’è la volontà di sorprendere il lettore. Semmai quella di farlo partecipe della dimensione affettiva del protagonista.
E ciò avviene grazie alla spontaneità del registro linguistico.
Nonostante la presenza di un’ottima letterarietà, di una lingua filtrata dalla tradizione, l’autore aderisce con naturalezza alla parlata della sua gente.
Pur non facendo uso del dialetto.
E ciò, grazie alla sua abilità di traduttore.
Che dire infine della poetica di Pavese?
La sua opera è ampia e varia, e dai contenuti ricorrenti.
Uno per tutti: la scoperta dell’infanzia, vissuta come l’età in cui l’uomo compie le esperienze fondamentali.
Perchè è durante l’infanzia che si stabilisce il primo contatto con il mondo.
Ed è in quel periodo che si creano i simboli, e che a sua volta diventano miti.