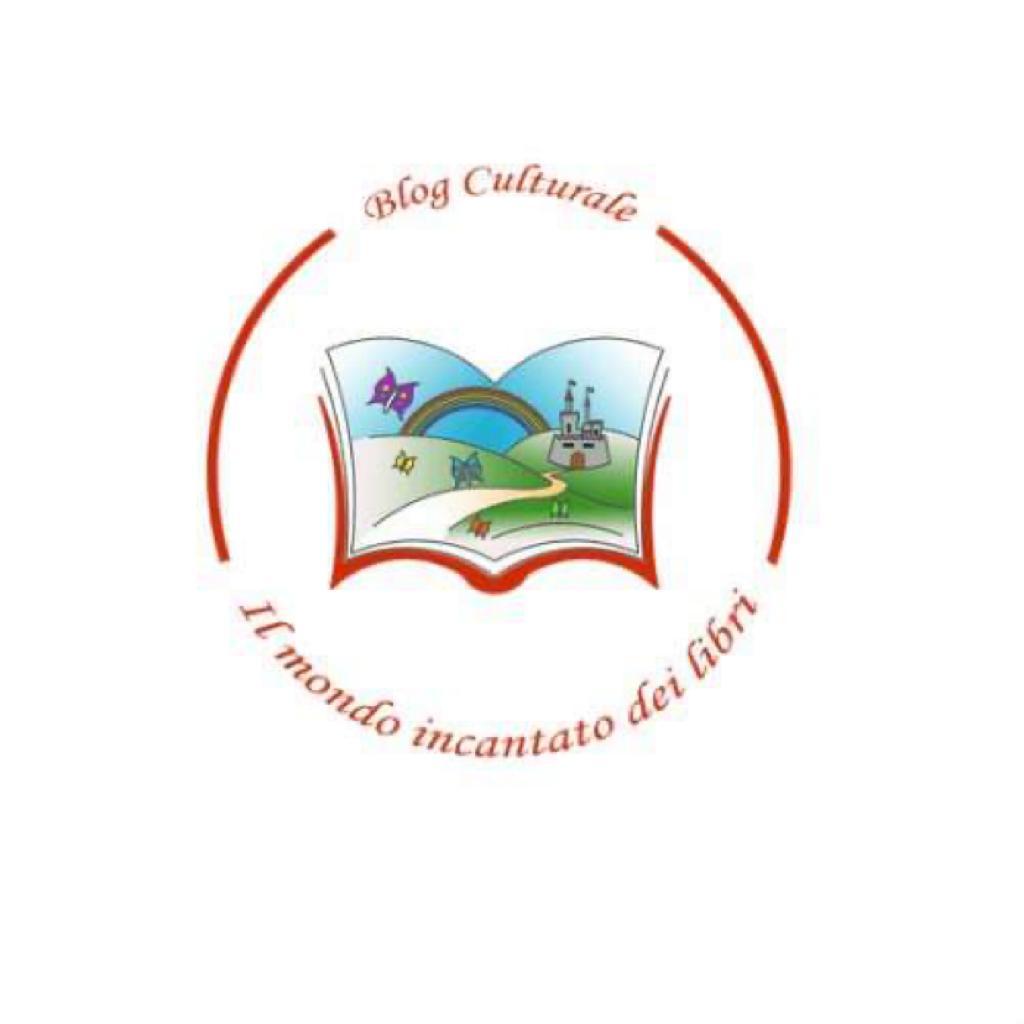Il tempio delle divinità private
VANYA DE ROSA·LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 2015
(Un contributo personale alla giornata di oggi, 2 novembre, dedicata a chi non c’è più. La narratrice è una professoressa di latino e greco prossima alla pensione, che ha perso da un anno il marito, suo insegnante ai tempi del liceo. Il linguaggio e lo stile narrativo sono adattati al personaggio. Questa è la parte iniziale del racconto.)
Ai miei tempi esisteva un netto confine tra le stagioni. Ricordo che quand’ero ragazza l’inverno ci assaliva tagliente come una lama affilata e le ginocchia nude sopra i calzini diventavano violacee mentre raggiungevo il liceo vicino al mare. Ma camminavo a passo svelto perché il sangue scorresse più vivo nelle vene, e guardando fisso lo specchio smosso di acqua ghiaccia mi pareva di intravedere, là in fondo, un varco nelle nuvole grevi.
Ora è gennaio, e però una cortina di spessore umido vela di nebbia quello stesso orizzonte, tanto che il mare e il cielo si confondono in un unico, latteo biancore. Percorro i marciapiedi con cautela e le gambe si affaticano affrontando come ogni mattina la scalinata di pietra consunta. Man mano che quest’altro anno di scuola si scioglie mi sento sempre più stanca e stento a rincorrere l’adolescente dalle ginocchia livide che da lontano ride di scherno e mi indirizza sberleffi.
Paolo continua a chiamarmi tutte le sere. Ad ogni telefonata mi ripete il medesimo discorso, insiste perché io vada in pensione e mi trasferisca a Milano, a casa sua, o in un appartamento per conto mio, se preferisco, da quelle parti, o anche in un altro quartiere, purché sia nella stessa città, vicino a lui, a Laura, al bambino che chiede sempre della nonna, purché non me ne resti più così lontana, sola da quasi un anno in quella casa disseminata di ricordi.
Eppure è lì che io mi sento viva, in quelle stanze, fra le stazioni di un percorso simbolico che per me, e per me sola, possiede un significato. I vestiti di Mauro ancora impregnati di profumi familiari, un rettangolo più bianco sulla parete dove lui ha rimosso un quadro per appenderne un altro che non ha mai comprato, il quotidiano spiegato sulla scrivania, con la data di quel giorno, e gli occhiali da lettura posati sopra con cura, quasi sapesse, un attimo prima che il cuore all’improvviso si fermasse. Più i mesi si susseguono impietosi, più il mio intimo cammino procede a ritroso, e mi aggiro in quel tempio di divinità private celebrando riti che evocano dal vuoto segni di presenza. I medici, con il loro linguaggio scarno e senza scarti, parlerebbero di depressione. Invece io, mai stanca di creare visioni, vedo la mia vita di adesso condensata in un’immagine, quella del Piccolo Carro che in una notte limpida distinsi con chiarezza dal ponte di un traghetto, mentre avvolta da tanto buio inafferrabile di mare e di cielo navigavo verso la Grecia. Allora la interpretai come un segnale, debole faro sospeso in un’immensità nera, e mi sembrò di ritrovare poi le stesse luci nel porto affollato di Patrasso, tra le sue braccia che mi stringevano.
Quel disegno misterioso, ora, è l’itinerario del mio pellegrinaggio. Quattro angoli fissi, il recinto della nostra casa affacciata sul mare, e appena fuori una sola via, lungo lo stesso mare, che conduce alla meta estrema del viaggio, la scuola di pietra sempre uguale dove ogni giorno confronto la mia antica storia con le nuove e la rivivo. Calpesto i pavimenti corrosi che la ragazza dalle ginocchia livide calpestava, mi appoggio al davanzale della finestra sul lungomare e rivedo, adagiata sul marmo opaco, la sua piccola mano ancora liscia che il giovane supplente di latino e greco, una volta, aveva accarezzato. E lei, figlia perbene di genitori severi e timorati di Dio, che si sarebbe segnata mille volte prima di pensare ad una cosa come quella, aveva fatto l’amore con lui lo stesso giorno, e le era parso naturale. Terminata la mattina di lavoro di nuovo m’incammino per la strada sul mare, m’immergo da un lato nella frenesia del mondo dei frammenti e dei rumori, dall’altro, voltando lo sguardo, assaporo l’infinito. E infine risalgo verso l’attico con la terrazza aperta sul litorale, il nostro osservatorio privato sulle profondità di una fetta di universo, a lungo desiderato, scelto insieme.
Ci sono state tante sere negli anni trascorsi, allora ordinarie, che ora ricordo come momenti di percezione intensa, quando affacciati su quell’oscurità, vellutata a volte, e a volte furibonda, più affascinante delle luci tentatrici che la abbracciavano, respiravamo il suo odore all’unisono, un essere solo, io e lui, mio marito maestro, padre, amante. Guardando l’orizzonte senza fondo immaginavo terre invisibili eppure vicine, i tempi della storia si fondevano in quell’unico respiro, e mi sembrava di riuscire ad afferrare il senso delle cose.
Se guardo adesso quella distesa cupa ed inquietante, e i lumi delle imbarcazioni qua e là che paiono vagare in sospensione, vedo soltanto un cimitero immenso, e un buco nero che ingoia ogni spasimo di vita e sparge il vuoto intorno.
(dal mio racconto “Il Piccolo Carro”, nell’e-book “Voci dalla Rete 2”, Longanesi, 2002)