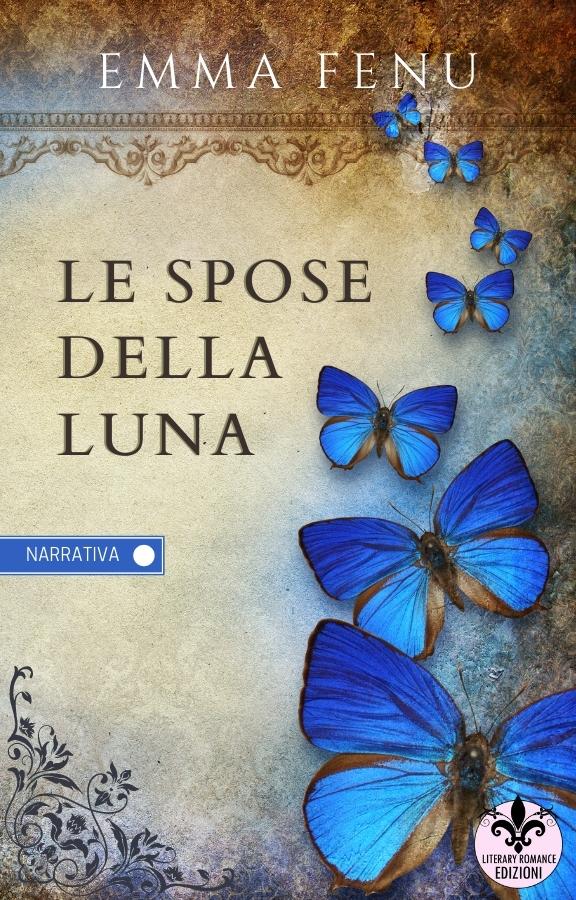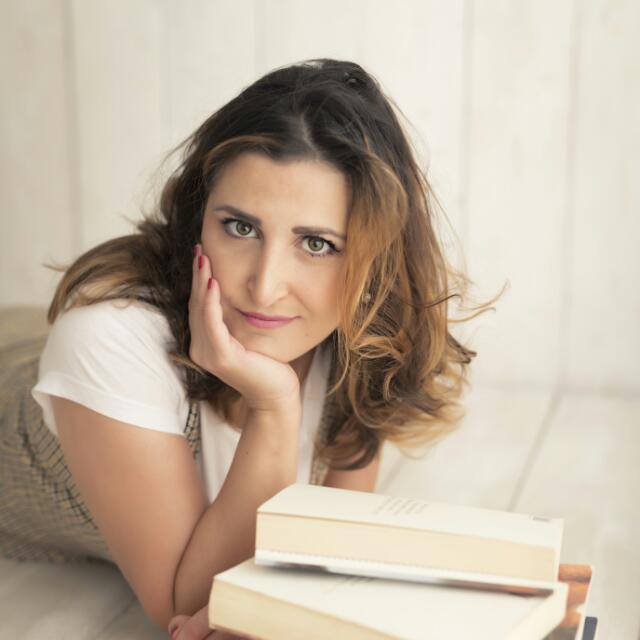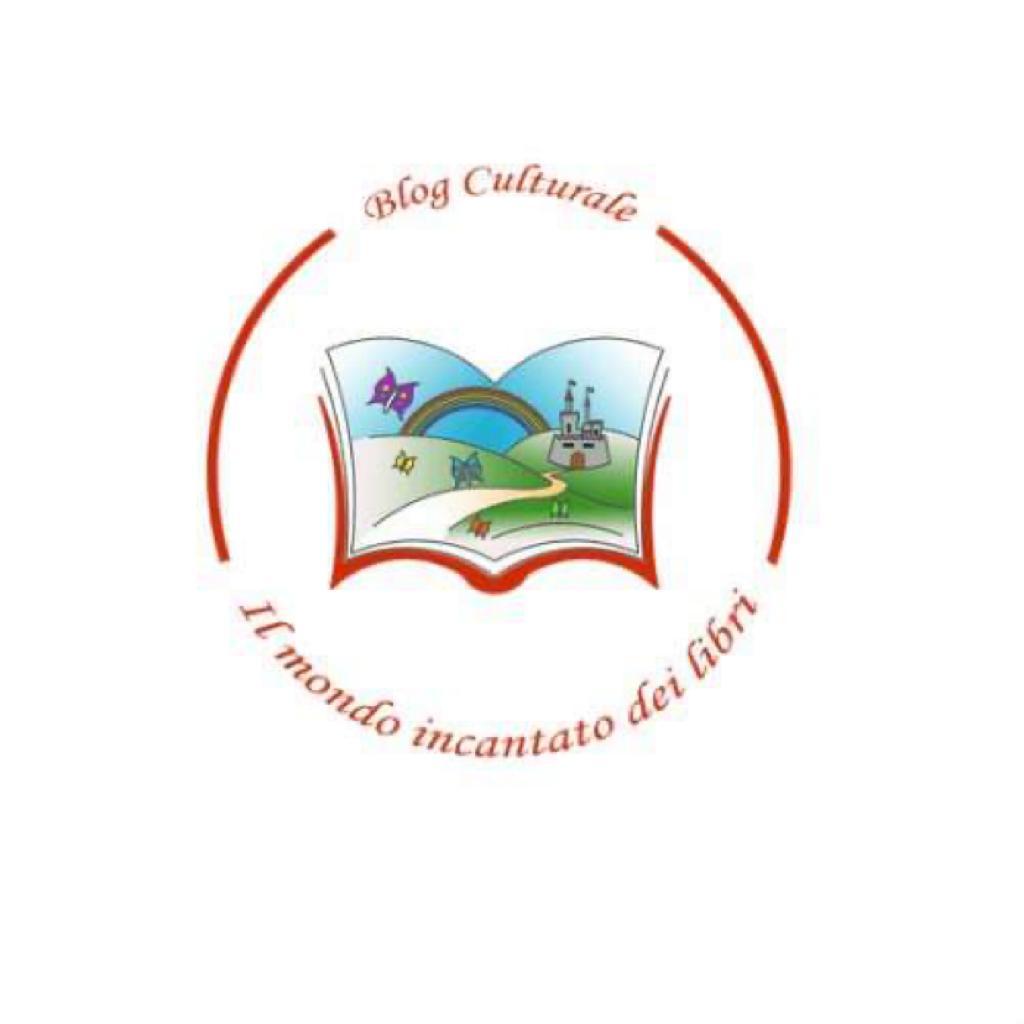Introduzione a Simone de Beauvoir
Perché Simone de Beauvoir parla alle donne di oggi
di Paola Caramadre
L’autunno del 2016 lo ricorderemo come l’autunno delle donne. Ne faremo memoria. Ci sfileranno davanti agli occhi le donne protagoniste di cortei e animatrici di manifestazioni a difesa delle donne. Ma chi sono le donne di oggi? Quali maestre hanno avuto, se ne hanno avute? Che cosa è una donna, oggi? La stessa domanda è stata formulata nel 1949 e ha rappresentato l’inizio di un cambiamento radicale.
“Che cosa è una donna? L’enunciazione stessa del problema mi suggerisce subito una prima risposta. È significativo che io lo proponga. A un uomo non verrebbe mai in mente di scrivere un libro sulla singolare posizione che i maschi hanno nell’umanità. Se io voglio definirmi, sono obbligata anzitutto a dichiarare: Sono una donna; questa verità costituisce il fondo sul quale si ancorerà ogni altra affermazione”.
Queste sono le parole che Simone de Beauvoir scrive nell’introduzione al saggio Il secondo sesso che diventerà il testo più dibattuto del pensiero femminista. Per la stessa autrice, Il secondo sesso sarà la chiave di volta per la sua scrittura e segnerà, nell’opinione pubblica, l’affrancamento del proprio ruolo, se così si può dire, da Jean-Paul Sartre.
Con la pubblicazione del saggio, Simone de Beauvoir conquisterà un posto di primo piano nella letteratura militante europea assumendo una autonomia di pensiero e di scrittura rispetto all’autore de La Nausea.
L’amore è da reinventare!
Simone de Beauvoir nasce in una famiglia benestante nel 1908, suo padre è un avvocato e sua madre è il modello al quale, fin dalla prima infanzia, si ribella. La madre incarna ciò che la piccola Simone non vuole diventare. Il suo sogno è quello di diventare una scrittrice celebre. L’infanzia e l’adolescenza quasi dorate, comunque felici, grazie all’affetto per la sorella Hélène hanno un epilogo drammatico segnato da un lutto dolorissimo, la morte della sua migliore amica, Elizabeth. L’insofferenza ad una educazione cattolica fa scaturire come reazione quella di gettarsi nello studio con dedizione.
All’università incontra filosofi come Merleau-Ponty, Levy-Strauss, conosce scrittori come André Gide e Paul Nizan e soprattutto conosce Jean-Paul Sartre. Quest’ultimo, datato 1929, è l’incontro della vita, quello fondamentale. L’inizio di un percorso che porterà i due intellettuali ad avere un ruolo di primo piano nella scena internazionale. Il loro legame, profondo e descritto in ogni dettaglio dalla stessa de Beauvoir, non sarà mai vincolato da contratti. Non si sposeranno mai, ed è lei a rifiutare la proposta, ma la loro unione durerà fino al 1980, anno della morte di Sartre.
Contro ogni convenzione, contro ogni dettame della società borghese, la de Beauvoir usa la sincerità verso se stessi e verso gli altri. Ed è la sincerità il fondamento del patto stretto con Sartre:
Non soltanto nessuno dei due avrebbe mai mentito all’altro, ma non gli avrebbe mai dissimulato niente.
La politica entra dirompente nella vita privata. Il clima culturale parigino è vivace e in costante fermento. Tutto sembra possibile. Rovesciare i ruoli, riscrivere la storia. Nemmeno l’occupazione nazista di Parigi riesce a spezzare quei meccanismi ormai innescati. Le istanze coltivate nella guerra civile spagnola subiscono una battuta d’arresto, ma aspettano di riemergere con la Liberazione. La stessa de Beauvoir è parte integrante di questo processo di trasformazione e di ribaltamento degli scenari. Anche nella vita privata.
Dare testimonianza
La guerra civile in Spagna e poi la seconda guerra mondiale la vedono non protagonista attiva, ma spettatrice attenta e sensibile. Durante l’occupazione tedesca a Parigi scrive il suo romanzo d’esordio L’invitata, pubblicato nel 1943. In quello stesso anno lascia l’insegnamento e decide di dedicarsi esclusivamente alla scrittura.
La scrittura diventa la sua vita e nella scrittura si riversa tutto ciò che vive. Il suo impegno morale è quello di ‘dare testimonianza’ da intellettuale militante. Subito dopo la liberazione pubblica Il sangue degli altri. Insieme al suo compagno di vita, di scrittura e di filosofia viaggia molto in Spagna, in Italia, in Grecia, in Marocco. I mandarini è il romanzo che la incorona scrittrice di fama e per il quale riceve premi prestigiosi come il Goncourt. Nel 1949, la pubblicazione del saggio Il secondo sesso segna una trasformazione della percezione che l’opinione pubblica ha di Simone De Beauvoir, esce dall’ombra di Sartre e diventa un punto di riferimento per il movimento femminista agli albori. Gli anni ’50 consacrano la vivace e curiosa scrittrice come polemista, mai acritica, mai apatica spettatrice. Prendere posizione è il suo codice. Compie molti viaggi a Cuba, in Brasile, Russia, Cina e negli Stati Uniti che documenta e che diventano materiale per i suoi scritti.
Scrivere è vivere
Di ogni viaggio, di ogni discussione, di ogni dibattito restano tracce profonde nelle sue opere. L’opera della De Beauvoir è soprattutto autobiografica. Scrive di se stessa, delle persone che la circondano, senza censure ma con la sincerità e l’autenticità che ha inseguito per tutta la vita. La malattia e la morte della madre diventano materiale per il romanzo Una morte dolcissima, la vecchiaia viene affrontata nel saggio La terza età, gli ultimi dieci anni di vita accanto a Sartre diventano La cerimonia degli addii scritto dopo la morte dello scrittore avvenuta nel 1980. Una vita intensa, vissuta in prima persona, senza tirarsi mai indietro, al fianco degli intellettuali più rilevanti del ‘900.
Nessuno deciderà per te, neanche il destino,
questa frase scritta nel romanzo Il sangue degli altri è la chiave di una scrittrice che ha costruito il proprio destino.
La condizione femminile
Simone De Beauvoir compie una rivoluzione individuale: scrive da donna di politica, di filosofia, di sociologia. Scrive da donna di questioni maschili. Impone sul tavolo della discussione il punto di vista femminile e lo fa nel modo migliore possibile.
Donna non si nasce, si diventa,
è la sintesi più celebre, e anche la più esemplificativa, del pensiero della De Beauvoir. Leggere i suoi testi, da donna, non è facile. Significa mettersi in discussione, significa provare una vertigine, quella che provoca l’infinito prisma delle possibilità. Niente è vietato, niente è impossibile. La de Beauvoir individua il fulcro del problema nella rappresentazione che il maschile dà del femminile: il completamente altro, l’assolutamente diverso negando la potenzialità del dibattito e del confronto.
Analizza ogni punto, ogni aspetto dalla biologia ai miti, dal passato al presente e individua scenari futuri.
La libertà è intera in ognuno. Soltanto perché nella donna rimane astratta e vuota, non può essere autenticamente assunta che nella ribellione: è questa l’unica strada aperta a coloro che non hanno la possibilità di costruire niente; è necessario che rifiutino i limiti della loro situazione e cerchino di aprirsi le strade dell’avvenire; la rassegnazione non è che rinuncia e fuga; per la donna non c’è altro mezzo che lavorare sulla propria liberazione.
Questa liberazione non può che essere collettiva, ed esige prima di tutto che si compia l’evoluzione economica della condizione femminile.
Le sue parole hanno un senso compiuto. Sono l’eredità che trae origine da quel saggio Una stanza tutta per sé e si riformulano in un lascito che è soprattutto un punto di partenza che ci impone una domanda: Chi sono le donne, oggi?