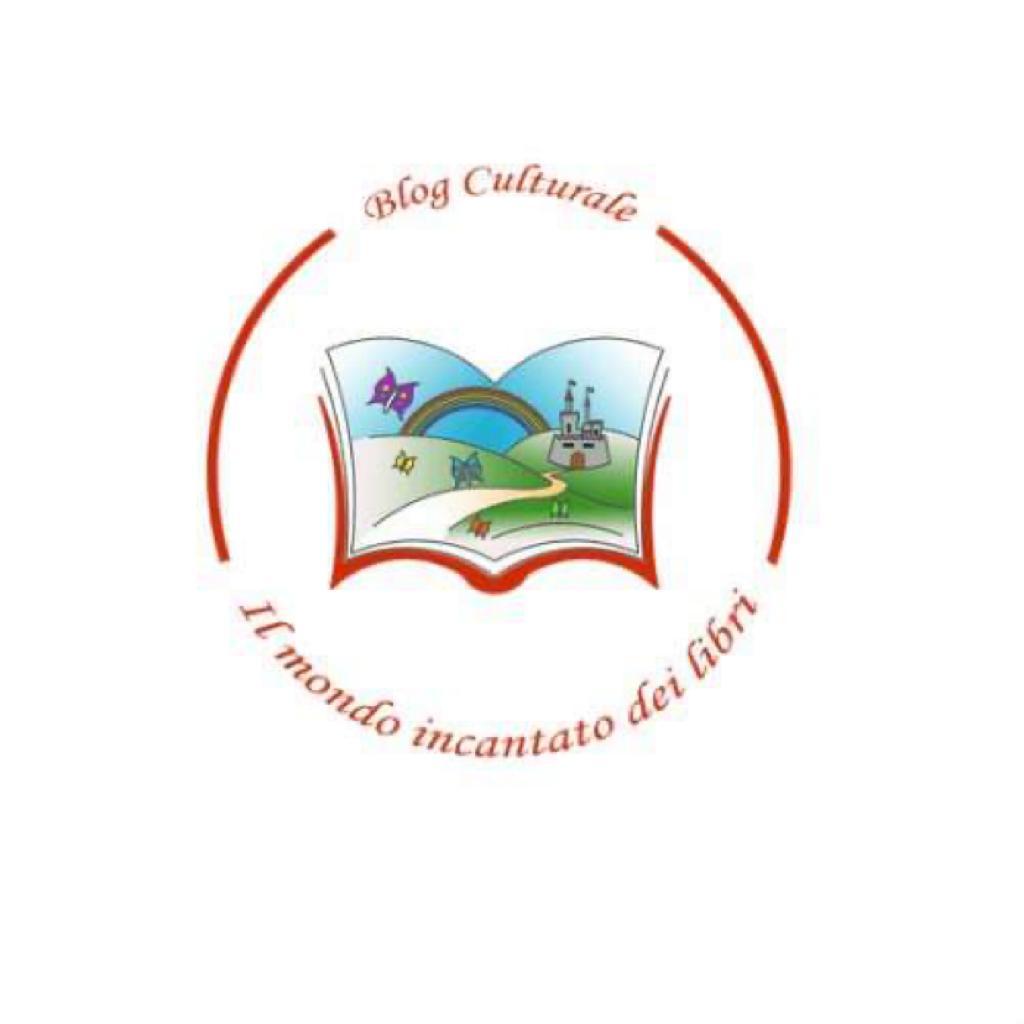Assaporo una zolletta di zucchero in segreto e, puntuale, arriva il ricordo che accompagna quel sapore.
Ho quattro anni e sono seduta sul sedile posteriore della Lancia Thema di mio nonno materno. Lui, con il suo sorriso smagliante, prende da un piccolo contenitore una zolletta di zucchero; poi me la porge accostando l’indice al naso e sussurrando “shhh, non lo dire alla mamma”. Io lascio che la zolletta si sciolga sulla lingua e sono felice.
È sempre stato cosí mio nonno, capace di ritagliare dei piccoli momenti di felicità con tutti quelli attorno a lui.
Quando sono nata io, la sua prima nipotina, lui scoppiava di felicità. Mi chiamava principessa, so che può sembrare un vezzeggiativo banale ma con lui niente lo era. Quando andavamo in vacanza insieme alla casa al mare, i miei momenti preferiti erano quelli trascorsi con lui. Avevamo un nascondiglio dove ci andavamo a rifugiare per ritagliarci del tempo per noi: un albero dalla strana forma di “U”, una corteccia che si biforcava in due parti e che lasciava giusto lo spazio per sedersi in mezzo.
Mio nonno allora mi sollevava e mi metteva a sedere proprio lì.
Cosa facevo io su un tronco deforme? Lo osservavo e lo ascoltavo cantare.
“Oje vita, oje vita mia,
oje core ‘e chistu core,
si’ stata ‘o primmo ammore
e ‘o primmo e ll’ùrdemo sarraje pe’ me.”
Mi dedicava sempre queste parole e ripeteva quella canzone una, due, infinite volte. Non me ne annoiavo mai.
Sempre durante il tempo trascorso nella casa al mare, mi insegnò ad andare in bici. Con pazienza mi fece abituare alle rotelle, che in breve tempo da due passarono a una sola. Quando sparì anche quella, mi teneva il sellino da dietro e camminava al mio fianco mentre io pedalavo, aiutandomi a mantenere l’equilibrio.
Se chiudo gli occhi e mi concentro, riesco a sentire il suono della sua voce mentre mi diceva “vai pedala, ti tengo io”, rivivo poi lo stupore di rendermi conto che, invece, mi aveva lasciata andare e che io, proprio io, avevo pedalato da sola e senza le rotelle.
Mio nonno ha anche avuto il riconoscimento di avermi insegnato a fischiare e a giocare a carte. Il fischiare è stato un successo, pochi bambini alla scuola materna ci riuscivano come me. Sul giocare a carte invece, povero nonno, gli ho dato ben poche soddisfazioni.
Tutti questi ricordi della mia infanzia vengono interrotti bruscamente nell’estate del 1998, poco prima del mio sesto compleanno. Il viaggio verso la casa al mare non fu tranquillo come al solito, fu piuttosto frettoloso e agitato perché mio nonno stava poco bene.
Non ricordo se riuscii a vederlo ricoverato, ma ricordo un lasso di tempo infinito in cui tutta la famiglia mi diceva che il nonno era via, in ospedale.
Io allora prendevo carta penna e gli scrivevo delle lettere, con la mia scrittura in stampatello grande e tremolante, “Nonno mi manchi, torna presto”. Poi, dicevo severamente a mia nonna “dai la lettera a Nonno Enzo”.
“Gliela darò”, rispondeva lei.
Ci vollero effettivamente diversi mesi prima che potessi riabbracciare mio nonno, nei suoi splendidi 59 anni di età. Quel momento è impresso in modo indelebile nella mia memoria: si materializzò nel salone dei miei nonni una figura alta, con i capelli tutti bianchi, grosse sopracciglia nere, occhi luminosi e sorriso bianchissimo, si accovacciò e mi prese in braccio mentre la nonna strillava “non ti sforzare!”.
“Perché ti agiti?”, rispose mio nonno senza scomporsi, “la vita tanto va come deve andare”.
Mi spiegarono che aveva avuto un infarto e avrebbe dovuto riguardarsi per il resto della sua vita, ma entrambi sapevamo che nulla lo avrebbe fermato.
Mi fa sorridere l’apprensione che gli mostrai negli anni a venire, come se quell’avvenimento, la malattia e l’allontanamento, avesse segnato un prima e un dopo: fino a quell’istante si era preso lui cura di me, ora volevo prendermi io cura di lui.
Quella premura reciproca non si fermò neanche in adolescenza, momento in cui da tutti gli altri parenti fuggivo e prendevo le distanze.
Spesso dopo il pranzo domenicale andavamo a fare una passeggiata su e giù per il parco, gli raccontavo della mia vita, lui ascoltava, capiva.
Fu lui a spiegarmi per la prima volta che le invidie femminili sono dettate da profonde insicurezze, fu lui ad aiutarmi ad accettare e apprezzare il mio corpo che cambiava ogni giorno. Mi insegnò ad amarmi e a rispettarmi e, soprattutto, ad allontanarmi da chi quella sicurezza me la toglieva.
Quando all’età di 14 anni i miei genitori si separarono, mio nonno venne a stare un po’ da noi. Si occupò della casa, di scarrozzare me e mio fratello in giro, accudì mia madre e l’aiutò a superare un forte crollo emotivo.
Allo stesso tempo, mantenne un buon rapporto con mio padre, pur rimproverandolo amaramente quando ci trascurava.
Spesso, quando veniva a prendermi il sabato sera, scambiava qualche chiacchiera con i miei amici. Sapeva sempre come creare una connessione: saltava facilmente da un argomento all’altro, dallo sport alla politica, dalla musica alla tecnologia. Amava sapere e guadagnava sempre la simpatia di tutti.
Per aiutarmi nella scelta universitaria, mio nonno passò intere mattine davanti al computer di casa sua a cercare informazioni. Stampava tutto con cura e raccoglieva i documenti in una cartella azzurra che portava il mio nome. Io li analizzavo e ne discutevamo a lungo.
Quando la scelta ricadde su ingegneria a Milano, mi fece solo una richiesta: non sposare un milanese. Era un modo simpatico per dire che avevo la sua approvazione, anche se in fondo lui sperava che avrei frequentato un napoletano e che prima o poi sarei tornata a casa.
Alla fine del mio primo anno universitario prese un treno alta velocità per venirmi a trovare. Ne era ammaliato, mi raccontava dei suoi agghiaccianti viaggi nei treni regionali che per tutta la vita lo avevano portato su e giù per l’Italia per svolgere il suo lavoro di rappresentante aziendale.
Prese una stanza nella residenza universitaria dove vivevo, non si lamentò mai dei piedi che gli penzolavano fuori da quel letto minuscolo o del chiacchiericcio degli studenti fino a tarda notte. Lui voleva vedere dove e come vivevo, il percorso che facevo per andare all’università, per fare la spesa, dove mi riunivo a studiare. Tranquillizzò lui mia nonna dicendo “si è organizzata bene, è tutta suo nonno!”
Anche il primo aereo della sua vita lo prese per me, nonostante il cuore fragile e gli anni che passavano. Aveva insistito molto affinché non andassi a prenderlo agli arrivi di un periferico aeroporto di Londra, città dove lavoravo.
Quando lo vidi sull’uscio di casa mia mi raccontò di aver fatto amicizia con l’autista iraniano dell’autobus che lo aveva portato lì, che aveva aperto le porte per lui proprio fuori il mio cancello affinché non si perdesse, anche se la fermata era distante pochi metri.
Ricordo che una volta in metro rimase affascinato da tutte quelle etnie diverse che si mescolavano nella capitale inglese e mi sussurrò all’orecchio “siamo tali e quali, è inutile affannarsi nel cercare differenze”.
Mio nonno ha compiuto 80 anni quando mi sono trasferita a Madrid e, ahimè, il suo gracile corpo non gli permise di vernirmi a trovare. Lui però, che nello spirito continuava ad essere un guerriero, comprò uno smartphone e imparò a videochiamare, così l’ho potuto portare a spasso con me per la città diverse volte.
Da quello schermo piccolo aveva comunque colto tutte le similitudini tra Napoli e Madrid e questo un po’ lo rincuorò, come se in qualche modo fossi davvero tornata a casa.
Sono passati pochi mesi da quei momenti ma qualche notte fa mia madre mi ha telefonato per avvertirmi che mio nonno era stato ricoverato per un forte dolore al petto.
Senza quasi avvisare il mio superiore, mi sono precipitata a casa. Quando lui mi ha vista entrare nella sua stanza, con una flebile voce ha sussurrato “sei venuta”.
“Grazie per avermi aspettata”, ho risposto io. Ho passato molte notti in ospedale con lui, alternandomi a mia madre e mia zia, leggendogli il giornale ogni giorno come piaceva a lui, aiutandolo a mangiare fino a quando è rimasto sveglio.
Sono qui al suo fianco anche adesso che è attaccato a una macchina e non può neanche aprire gli occhi. Dicono i medici che ormai manca poco alla fine.
Quello che per gli altri è un uomo al tramonto della sua vita, inalando i suoi ultimi respiri, a me sembra comunque più pieno di vita di tutti noi.
Se però la nostalgia prende il sopravvento, se sento il bisogno di salutarlo ancora una volta, allora so esattamente cosa fare: prendo dalla tasca un piccolo contenitore, estraggo una zolletta di zucchero, la assaporo e torno ad essere una bambina di quattro anni seduta sul sedile posteriore della Lancia Thema di mio nonno Enzo.
Mio nonno non l’ho più rivisto dopo quell’estate del 1998: un infarto lo ha portato via all’età di 59 anni. Nonostante conservi suoi ricordi solo fino al mio sesto anno di vita, continua ad essere il più grande esempio di amore incondizionato che abbia conosciuto: tutt’ora mi commuovo ascoltando “’o surdato ‘nnammurato” (la canzone che mi cantava da piccola) e mia nonna ha incorniciato le lettere che gli scrivevo quando mi dicevano che era in ospedale, non trovando il coraggio di dirmi della sua morte.
In questo racconto ho voluto immaginare come la sua vita si sarebbe intrecciata alla mia se invece fosse sopravvissuto e, infine, come sarebbe stato potergli dire addio in maniera consapevole, in età adulta. Ho voluto insomma, attraverso la mia penna, dargli un’altra possibilità.
Perché mio nonno Enzo, credetemi, la meritava.