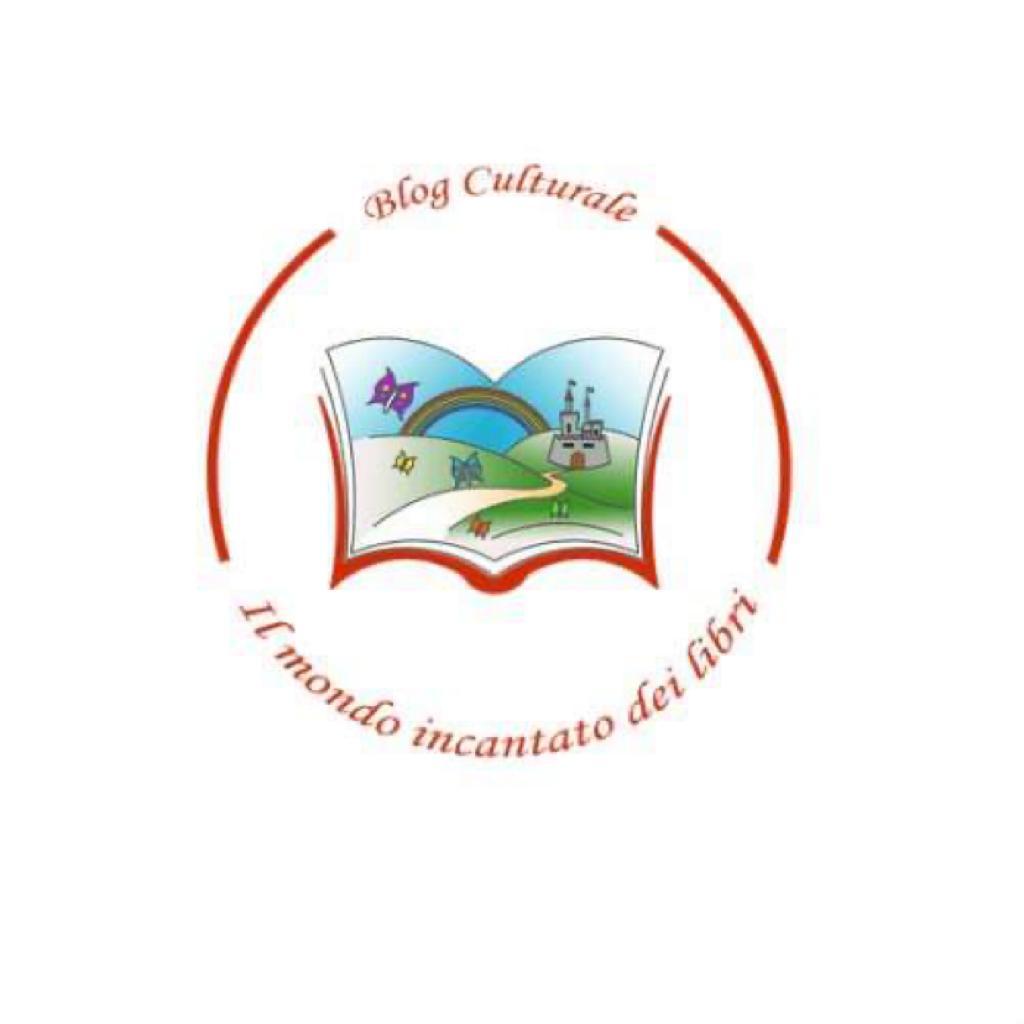Avrei potuto trovarmi in qualsiasi parte del mondo, ma quando sentivo le campane suonare il mio essere più profondo era come scaraventato a Susa in una sorta di teletrasporto.
Subito avvertivo nell’aria quel profumo di montagna, i tonfi della Dora che irrompevano sui sassi levigati e bianchi e annusando l’aria riuscivo persino a riconoscerne il profumo.
Come se stessi vivendo una realtà parallela, mi ritrovavo proprio su quel ponte dove c’era un’edicola, piccina piccina, che conteneva meraviglie per noi bambini.
E tornando a casa con il giornaletto preferito che profumava di carta, passeggiavo sul lungo Dora avvertendo l’aroma intenso dei fichi che maturavano ad inizio estate.
“Un Paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.”
Scrive Cesare Pavese nel suo racconto intitolato “La luna e i falò”.
Quello stesso effetto mi faceva quando infine tornavo a Susa, ormai adulta, per dare un saluto ai morti. Uscivo dal camposanto e trovavo sempre il modo di passare davanti alla nostra casa per osservare quel lungo balcone su cui avevo corso mille estati.
Una volta mi ero persino azzardata a salire le scale per vedere che effetto mi avrebbe fatto guardare quei gradini su cui, tanti anni prima ero caduta; e una volta, giunta fin lì, ero rimasta ad annusare l’aria, immobile, aspettando di vedere se da quelle porte sarebbe uscita Doni con i suoi riccioli biondi e disordinati, oppure sua sorella Mara che pur avendo solo dieci anni cuoceva il minestrone meglio di sua madre.
Mio fratello, che indossava scomode scarpe ortopediche, aveva il passo pesante e quando saliva quei gradini faceva tremare tutta la scala, tanto che il rumore sordo dei suoi passi veniva avvertito fino all’ultimo piano; ci abitava una signora mezza cieca che mi aveva massaggiato la caviglia con l’olio caldo quella volta che ero caduta per le scale.
“Maria, chiudi la porta che sto facendo il bagno!” – urlava alla figlia per timore che mio fratello, entrando, la vedesse mezza nuda e intenta a lavarsi dentro la grossa bacinella smaltata che teneva in cucina.
Ero rimasta ferma su quei gradini indecisa se restare, provare a suonare qualche campanello, chiedere se potevo entrare, vedere chi ci abitava; oppure scappare via come una ladra, tanto era evidente che nulla era più come prima in quell’appartamento al secondo piano i cui pavimenti, ricoperti da lunghe assi di legno, scricchiolavano ad ogni passo, facendomi svegliare in piena notte in preda agli incubi.
Ma chi occupava quelle stanze? C’era ancora la mia altalena sul lungo balcone? Ricordo che l’aveva creata mia nonna come dal nulla, le era bastato far passare una corda attorno ai ferri che reggevano la ringhiera e posarci sopra un cuscino.
Ma come si permettevano, quegli sconosciuti, di usare la mia altalena? E che ne sapevano, loro, dei miei discorsi con le rondini?
Alle prime nebbie d’autunno si riunivano nelle rientranze del tetto per discutere la via più breve per raggiungere il caldo.
Io le ascoltavo, le rondini, e capivo perfettamente quando erano pronte a partire; ma come spiegarlo a quegli sconosciuti, senza che mi prendessero per matta…
No, tanto valeva andar via, non aveva senso dialogare con chi ora viveva nelle nostre stanze, respirava l’aria della nostra casa, camminava su quelle stesse assi di legno.
No, non era giusto, anzi era crudele.
Le case in cui si è vissuto non dovrebbero essere abitate da altri perché erano pregne della nostra anima e del nostro passato; perché in quegli spazi riecheggiavano le nostre voci, rimbalzavano le nostre risate, canticchiava la radio la domenica mattina.
Le case in cui si è vissuto dovrebbero rimanere disabitate e diventare musei personali, luoghi privati in cui poter tornare a proprio piacimento per rivivere il passato.
Questo stavo pensando quando, ad un tratto, si era aperta una porta e ne era uscita una bambina con i calzoncini blu e la maglietta a righe colorate.
I suoi occhi scuri luccicavano allegri sotto una frangetta sbarazzina, mentre mi passava accanto senza riconoscermi, senza capire che eravamo sangue dello stesso sangue.