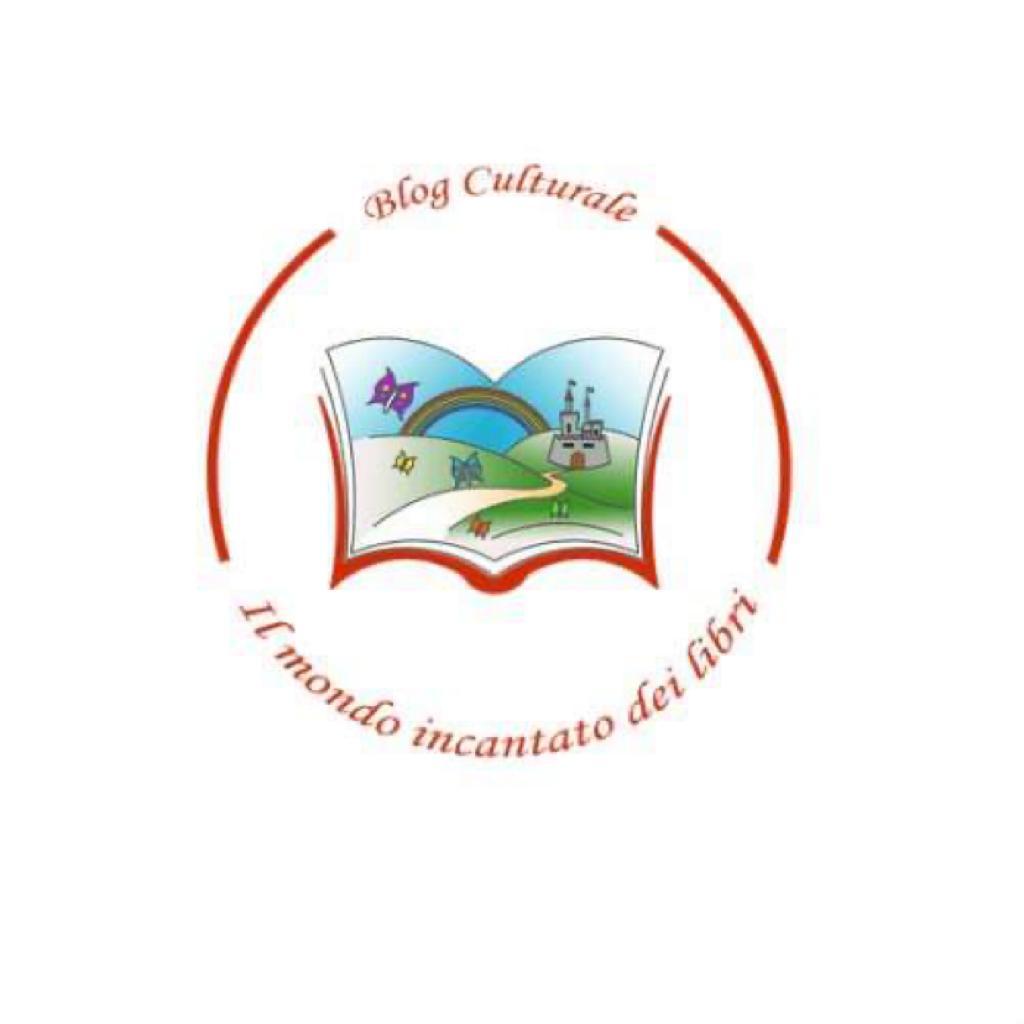“L’ultimo mercoledì a New York” di Luana Natalizi

Camminiamo piano nel silenzio di quella prima neve inaspettata. Per mano, attraversando Central Park, da sud a nord.
Camminiamo silenziosi nel piattume di una giornata autunnale, che all’alba è diventata carica di gelo ed è esplosa in fiocchi di neve ed in lacrime troppo dolorose, anche per cadere dagli occhi.
Camminiamo pensando alle cose dette, senza parlarne più, messi in stand by dal nostro modo civile di bloccarci prima che si degeneri e soprattutto prima che si incanti il disco per cui “tu neghi tutto e io vedo nero”.
Siamo immersi nel silenzio: del fuori dalla finestra, la neve ormai ridotta a pulviscolo; del fuori di noi, ognuno finto affaccendato e di spalle; e del dentro di noi, ognuno a continuare discorsi senza fiato.
Mi hai detto: “andiamo a prendere i biglietti?”
Già i biglietti! È il nostro ultimo mercoledì a New York, c’è l’Apollo stasera! Già.
Per tigna ti avrei voluto dire che non ne avevo voglia, ma erano cose che avrei fatto alcuni uomini fa… Oggi tra una ripicca e una gioia non ho dubbi.
“Va bene” ti ho risposto. Usciamo in fretta, due isolati con le mani in tasca, poi appena spingo il tasto del semaforo mi afferri una mano. Non ti guardo. Lo so come fai. Cerchi di sorridere, ti è passato tutto… a te. E tieniti questa mano, se ti rassicura, se non hai capito che ti scappo dalla testa e non dalle braccia. Se ancora non capisci che ti sfuggo dal cuore e non dalle dita, anzi mi fai fuggire tu con la tua lama di gelo, come il venticello che si alza adesso tra gli alberi e si porta la neve dei rami. Un vento che pesa come pesano le tue parole, secche e sferzanti.
Questo silenzio durerà perché dalla Julliard dobbiamo uscire ad Haarlem, ma non costeggiando il parco ad est. Senza chiedere, nonostante la neve, stiamo passando nel parco, sai che voglio camminare sempre negli Strawberry Fields ogni volta che posso, guardare gli alberi e cercare gli scoiattoli, toccare l’erba, o la neve fresca, come ora.
Camminiamo. Ormai aspetto che tu dica qualcosa: che eri solo nervoso, che non pensi niente di quello che hai detto, che va tutto bene, che mi ami, che senza di me non vivi, che tutto il resto non importa niente. Come una canzone. E invece piccole delusioni si succedono a ogni silenzioso passo.
Ecco il cancello, arriviamo al semaforo, attraversiamo. Non mi lasci la mano che provo a sottrarti, neanche quando mi fermo alla vetrina di quello strano negozio di leggins dell’Apparel laminati, adatti solo ai telefilm anni 70 di poliziotti e prostitute.
Arriviamo al nostro teatro, ancora ci guardano stralunati perché non sembriamo turisti e ovviamente neanche locali. Spesso mi dici: “Prima o poi si abitueranno, quando un giorno saremo qui ogni mercoledì dello sconosciuto (quante ne racconti tu).”
“Vuoi mangiare del pollo?” Mi chiedi. Intendi in quel posto dove veniamo in genere.
“No” rispondo secca.
“Preferisci andare da Silvia?” riprovi. Il ristorante creolo sull’Harlem, vuoi intortarmi.
“Senti non ho voglia di mangiare, io vado a casa”.
E mi giro. “Ma dove vai ?” E mi afferri di nuovo. “Andiamo a casa” mi dici con dolcezza.
Mi batte il cuore, forse parlerai.
Rientriamo nel parco. Stesso silenzio, c’è il lago a destra, le papere intirizzite, io stranita.
Accelero. Voglio andarmene.
Tolgo la mano fingendo di dover fare una foto. Mi fermo, mi allontano, non è difficile incantarsi, tra i rami di cristallo tanto belli, splendenti nella luce bianca con un sole dietro che spinge flebile.
Alzo le braccia, scatto.
Ora ci sei tu intorno al mio busto, con le braccia serrate.
Ora ci sei tu che mi spingi sul tronco.
Ci sono io che mi faccio ruotare come una bambola, ancora una volta e che di tutte le parole che volevo sentire non ne chiedo nessuna, zittita da un bacio.