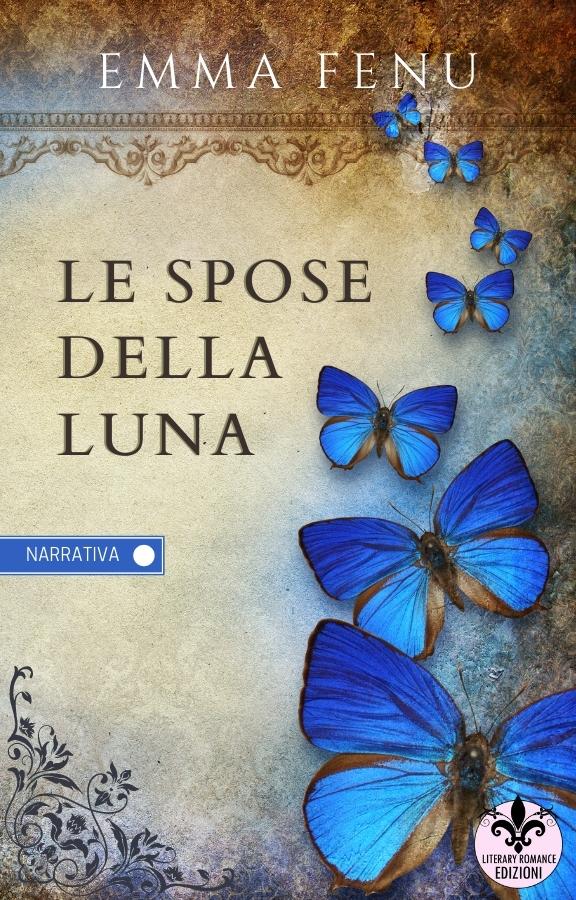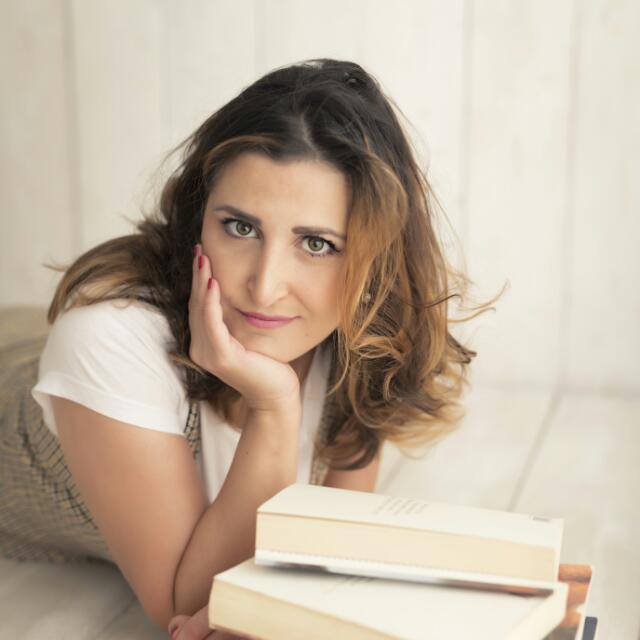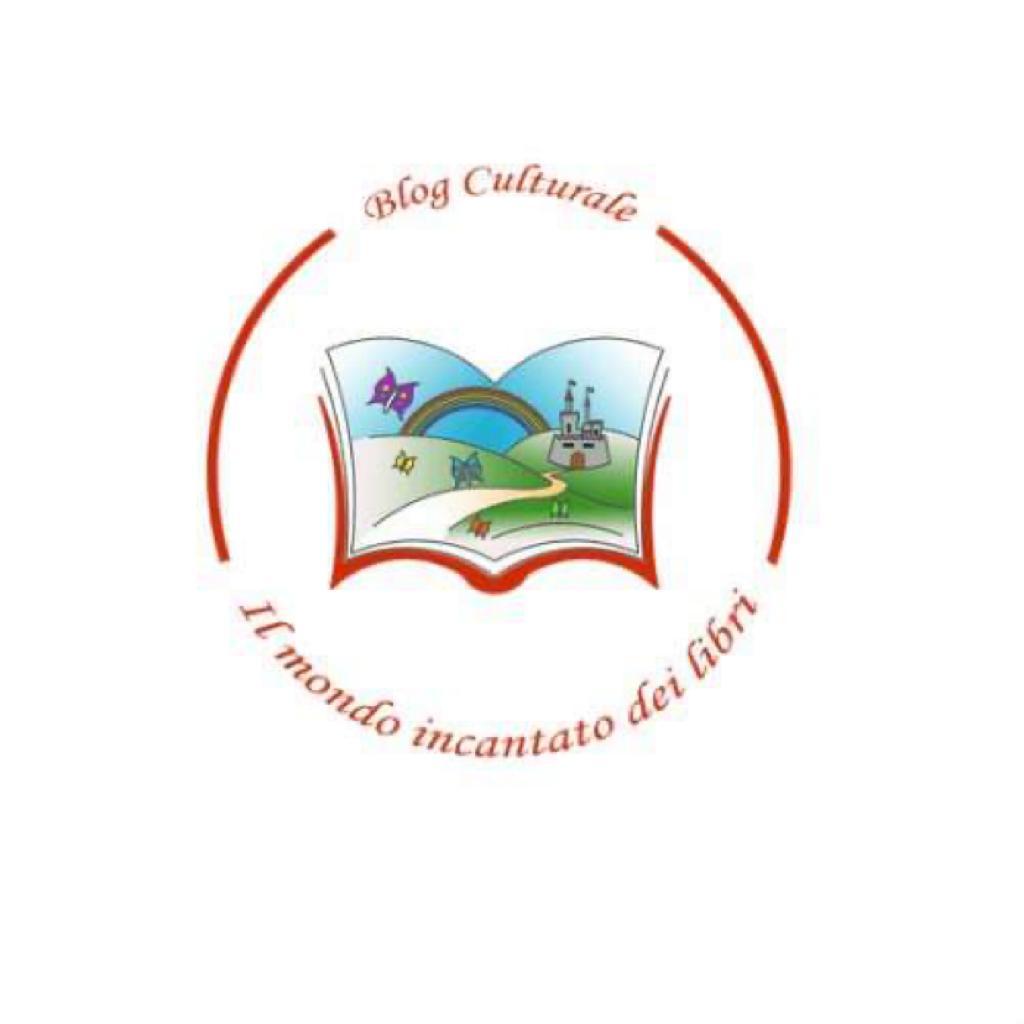Cesare Pavese. Una pietra miliare della letteratura italiana
di Giulia La Face

Cesare Pavese
Cesare Pavese è un autore di grande importanza e peso nella letteratura italiana. Per il rinnovamento nei contenuti, nello stile e nel linguaggio. Intellettuale, romanziere, poeta, importante traduttore di autori della letteratura inglese e americana.
Impossibile prescindere dalla sua figura per comprendere la letteratura italiana Egli a pieno titolo si inserisce, nonostante la “vicinanza” alla età contemporanea, tra i classici del Novecento.
Di lui si è scritto moltissimo. Fu definito un rappresentante del neorealismo italiano, poiché rivolse la sua attenzione alla realtà contemporanea e a luoghi geograficamente ben definiti .
Allo stesso tempo se ne discostò per la trasfigurazione lirica e simbolica che connota la sua osservazione.
E anche per la sfiducia che nutriva verso i progresso e la Storia.
Leggerlo oggi è un atto dovuto e necessario per comprendere la levatura e anche l’influenza che ha raggiunto i nostri giorni: la sua poetica e la sua capacità di dare vita e voci alla realtà attraverso il sentimento, la memoria, il simbolo, il magico.
La sua biografia è assai nota, anche perchè autore presente in tutte le moderne antologie scolastiche e in occasione del relativo recente centenario dalla sua nascita, riscoperto e riletto, criticamente e non, ovunque.
Nato in un paesino delle Langhe nel 1908, la sua vita è stata tormentata, sia a livello familiare e sentimentale che politico. Orfano di padre in età infantile, si fa risalire a questo trauma iniziale il carattere chiuso e scontroso di Pavese.
Qualunque sia l’interpretazione che si vuole dare a questi primi anni, non si può negare che si profila subito in essi la storia di un destino tragico e doloroso. Si manifesta una ricerca continua d’amore, di apertura verso gli altri, verso il mondo, verso le relazioni interpersonali. Nel contempo ci rende partecipi di un vissuto di solitudine, di amarezza, di disperata sconfitta.
Studierà a Torino, laureandosi giovanissimo nel 1930. Gli anni del liceo e poi dell’università hanno nella vita di Pavese il suggello dell’amicizia. Le dispute letterarie, l’eccitante accostamento al mondo vietato della politica, i caffé concerto. Poi ancora: i miti dell’industria cinematografica, le marce in collina, lo sport.

Immagine da web
In confronto al paese, la città si presenta come una festa continua.
Di giorno la vita è piena, i negozi sono tanti, i tram sferragliano e dovunque si ascolta musica.
Nel 1931 muore la madre, pochi mesi dopo la laurea. Grande è il rimorso di non averle manifestato ammirazione e affetto sufficienti. Rimasto solo, si trasferisce nell’abitazione della sorella Maria, presso la quale resterà fino alla morte.
Cesare Pavese si occupa di traduzioni, soprattutto della letteratura americana. Il mestiere di traduttore ha tale importanza non solo nella vita di Pavese ma per tutta la cultura. Di fatto apre uno spiraglio ad un periodo nuovo nella narrativa italiana.
Con le sue traduzioni, egli dà la misura di quanto sia grande la sua ansia di libertà.
Manifesta la sua esigenza di rompere lo schema delle retoriche nazionalistiche e apre nuovi orizzonti culturali, capaci di rinnovare l’immobile cultura italiana ancorata a vecchi clichè letterari.
Basti pensare come il fascismo negasse ogni iniziativa alle grandi masse.
Come coercizzasse l’uso della lingua. Esso condannava ed impediva gli scioperi, mentre in quei romanzi americani si leggeva la possibilità di creare nuovi rapporti sociali.
Contro la monotonia della prosa d’arte e diversamente dall’ermetismo, Pavese dimostrava come il contatto con le grandi masse americane attraverso quei romanzi vivificasse anche il linguaggio. Questo avveniva con l’inserimento della parlata popolare, così da renderlo congeniale con i nuovi contenuti.
Nel 1933 sorge la casa editrice Einaudi al cui progetto Cesare Pavese partecipa con entusiasmo per l’amicizia che lo lega a Giulio.
Questi sono gli anni dei suoi momenti migliori con «la donna dalla voce rauca». Si tratta di una intellettuale laureata in matematica e fortemente impegnata nella lotta antifascista.
Cesare accetta di far giungere al proprio domicilio lettere compromettenti sul piano politico. Scoperto, non fa il nome della donna e il 15 maggio 1935 viene condannato per sospetto antifascismo. Sconterà tre anni di confino a Brancaleone Calabro.
Tre anni che si ridurranno poi a meno di uno, per richiesta di grazia. Torna infatti dal confino nel marzo del 1936. Questo ritorno coincide con un’amara delusione: l’abbandono della donna e il matrimonio di lei con un altro.
L’esperienza (che sarà il soggetto del suo primo romanzo, “Il carcere”) e la delusione, lo fanno sprofondare in una crisi grave e profonda. Per anni resterà avvinto alla tentazione dolorosa e sempre presente del suicidio.
Si richiude in un isolamento forse peggiore di quello adolescenziale. Ma ancora una volta a salvarlo è la letteratura, il suo «valere alla penna».
Sono questi gli anni della prima raccolta poetica “Lavorare Stanca”, cui seguono i suoi romanzi e racconti.
L’avvento della guerra e dei suoi orrori, quando verrà poi destinato ad aprire una sede Einaudi a Roma, lo spingono a un doloroso ritiro nelle sue amate Langhe. Lì vivrà per due anni «recluso tra le colline», con un accenno di crisi religiosa e soprattutto con la certezza di essere diverso. Sentirà di non sapere partecipare alla vita, di non riuscire a essere attivo e presente, di non essere capace di avere ideali concreti per vivere.
Dopo la fine della guerra si iscrive al Partito comunista.
Ennesimo equivoco. Si illude di possedere quella capacità di aderenza alle cose, alle scelte, all’impegno, che invece gli mancavano. Era forse un tentativo e una voglia di mettere a posto la coscienza. Di fatto il suo impegno è sempre letterario: scrive articoli e saggi di ispirazione etico-civile, riprende il suo lavoro editoriale. Riorganizza la casa editrice Einaudi. Si occupa di mitologia e di etnologia, elaborando la sua teoria sul mito, concretizzata nei”Dialoghi con Leucò”.
Recatosi a Roma per lavoro ( dove soggiornerà per un periodo stabilmente, a parte qualche periodica evasione nelle Langhe) conosce una giovane attrice: Constance Dowling. Si innamora ancora.
Lei lo ammalia e poi va via, lo abbandona.
Costance torna in America e Cesare Pavese scrive “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi…”.

Pavese e Constance Dowling. Immagine da Web
A questo secondo abbandono, alle crisi politiche e religiose che riprendono a sconvolgerlo, allo sgomento e all’angoscia che lo assalgono nonostante i successi letterari ( nel 1938 “Il compagno” vince il premio Salento; nel 1949 “La bella estate” ottiene il premio Strega; pubblica “La luna e i falò” ), alla nuova ondata di solitudine e di senso di vuoto, non riesce più a reagire.
Logorato, stanco, ma lucido, Cesare Pavese si toglie la vita in una camera dell’ albergo Roma, a Torino. Ingoia una forte dose di barbiturici. È il 27 agosto del 1950. Lascia due righe sulla prima pagina dei “Dialoghi con Leucò”, sul comodino della stanza: «Perdono tutti e a tutti chiedo perdono…”. Pochi giorni prima aveva scritto questa profetica annotazione:
“Non ho più nulla da desiderare su questa terra, tranne quella cosa che quindici anni di fallimenti ormai escludono. Questo il consuntivo dell’anno non finito, che non finirò.”
Come si evince grande è la coincidenza della sua biografia con la espressione artistica e letteraria.
Nelle pagine dei suoi romanzi e racconti (“Paesi tuoi”, “La bella estate”, “La casa in collina”, “La luna e i falò”), nel diario (“Il mestiere di vivere”), nelle lettere, Pavese ha disegnato immagini di luoghi – Santo Stefano Belbo, le Langhe -.
Così come ha ritratto figure umane che in quei luoghi erano di casa o che da essi si erano allontanati per poi ritornarvi.
Vi troviamo le grandi tematiche della letteratura pavesiana: il mito, il tempo, tra passato cui tornare e futuro, apertura verso la realtà, il simbolo (tutto questo fa slittare la letteratura di Pavese oltre la definizione di Realismo che molta lettura “politica” dei suoi scritti ha voluto dare). Fu un grandissimo innovatore, ricercatore, sia linguisticamente che letterariamente. Questo è il grande lascito della sua arte.

Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo
Per esempio nel Mestiere di vivere , tra il 1942 e il 1943, parla di come devono essere strutturate le immagini.
Si concentra sulla necessità di utilizzare la commozione e sull’importanza del tempo presente e del passato. Riflette su come costruire un personaggio e come farlo parlare. Su come passare dalla semplice proposizione alla frase e come ottenere un racconto ben equilibrato. Notevoli sono gli appunti sullo stile, sulla lingua e sulla tecnica.
Pavese parla spesso di arte intesa come “mestiere” e la tecnica gli serve come autodisciplina per sfuggire alle tentazioni del romanticismo.
Con una scelta quindi che non intende solamente rispondere a canoni estetici ma soprattutto etici. Questi l’aiutano ad evitare di lasciarsi andare ad un semplice piacere narrativo.
“Pavese evita nelle sue opere tutte le forme romanzesche che si basano su costruzioni tradizionali come gli intrighi e i colpi di scena e costruisce storie che si basano su una trama narrativa quasi inesistente” (Marziano Guglielminetti)
A Pavese interessava rappresentare non tanto la realtà oggettiva delle cose ma quella che egli definiva la “realtà simbolica” , quella cioè che si nasconde al di sotto della esteriorità.
- “Ci vuole la ricchezza d’esperienze del realismo e la profondità di sensi del simbolismo. Tutta l’arte è un problema di equilibrio fra due opposti.”
Pavese unisce il concetto di simbolo con quello di mito. Quest’ultimo, stando alla filosofia pavesiana, si profila come l’obiettivo cui la poetica deve tendere. Rappresenta il mistero arcano, oscuro, da svelare. Rivela il lato selvaggio, truculento, riscoprendolo attraverso la memoria.
Leggendo Cesare Pavese ci imbattiamo in un desiderio, in un costante rimpianto dell’adolescenza ( fatto che lo rende accostabile, in un certo senso, a Giovanni Pascoli).
Ma mentre per altri questo “ritorno” è cosa possibile o comunque non messa in discussione, ma semplicemente attesa e ammirata, Pavese respinge questa possibilità, reputandola impossibile.
È questo il tema centrale del capolavoro pavesiano. L’impossibilità della consolazione nei miti dell’infanzia e della terra natale.

Pavese. Lastra dedicata
Ecco l’angoscia esistenziale profonda in cui è fondamentale la componente autobiografica e che Pavese fa emergere.
La sua ricerca di una verità, di una soluzione, di una consolazione impossibili, lascia una traccia nel suo ultimo romanzo, “La luna e i Falò”. Al protagonista affida una sorta di riflessione personale:
“Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.
http://www.fondazionecesarepavese.it/cesarepavese/cesarepavese.php
http://www.lafeltrinelli.it/libri/pierfranco-bruni/viaggio-omerico-cesare-pavese/9788887482393