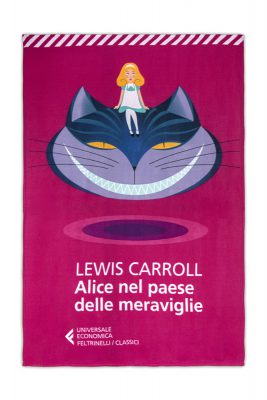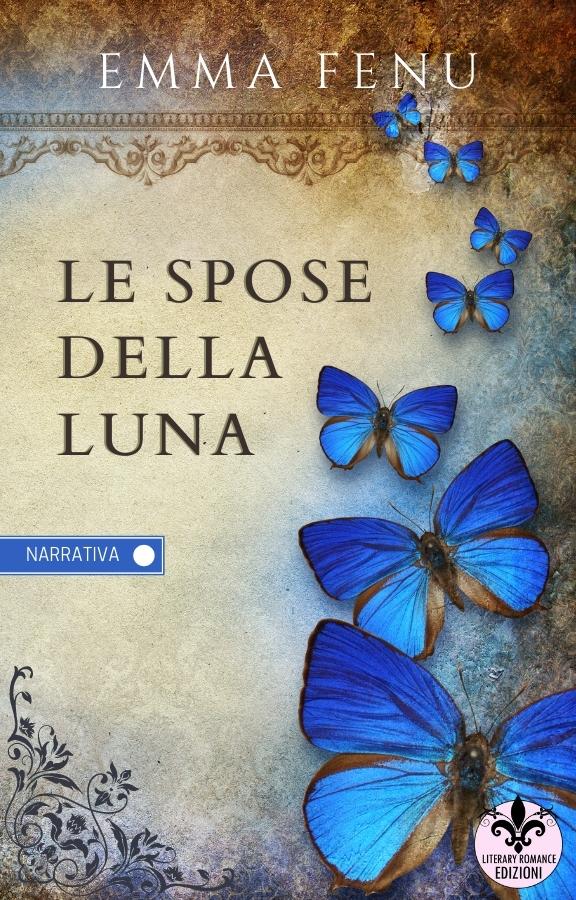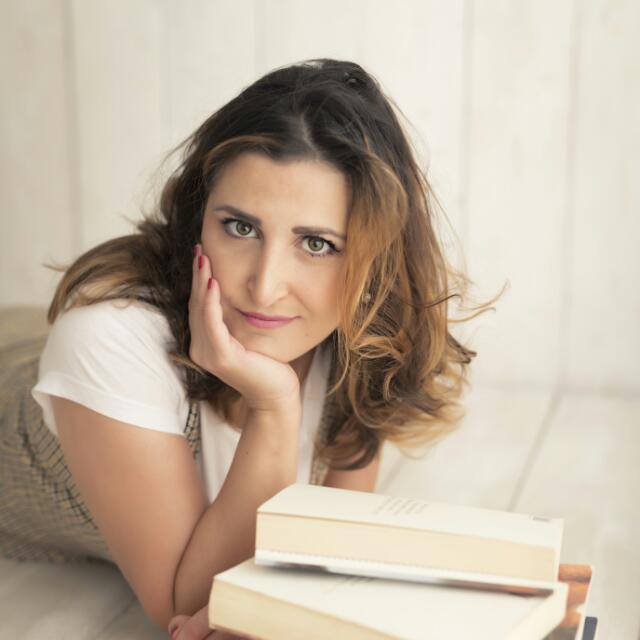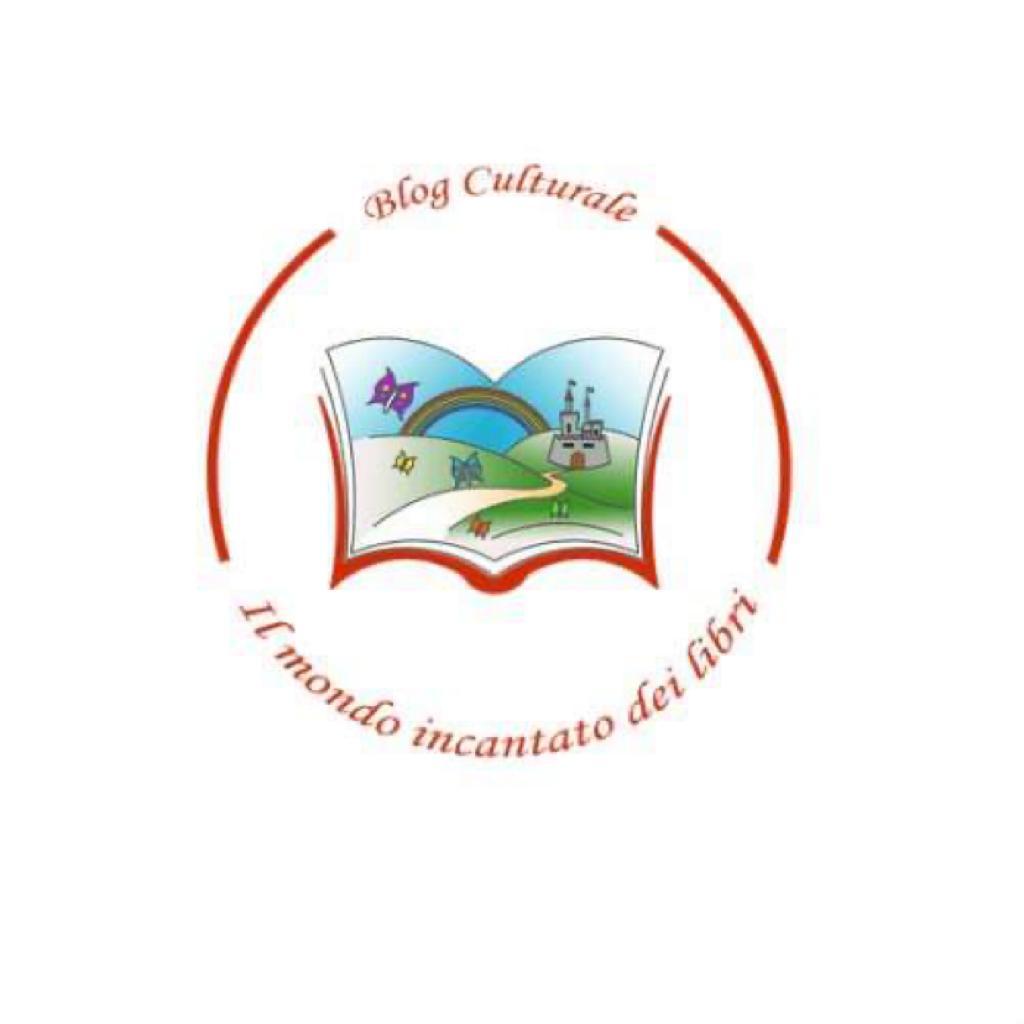Alice nel Paese delle Meraviglie – di Lewis Carroll
rubrica “Favola sarà lei!” di Mirella Morelli
Vorrei ricapitolare brevemente quanto detto finora a proposito della favola, ricordando con le parole del primo articolo di questa rubrica, Favola sarà lei, la differenza tra la fiaba e la favola.
Originariamente la favola nasce con una struttura lineare e uno schema semplice. Essa ha come protagonisti gli animali, le cui vicende possono intrecciarsi con quelle degli uomini – ma non necessariamente.
Ha tempi e luoghi sempre indefiniti: una valle, un bosco, un villaggio… Un tempo, una volta, un bel giorno…
Il finale in particolar modo è raramente lieto, anzi il debole soccombe al prepotente, può accadere che il protagonista muoia, e via così, in un epilogo quasi sempre amaro.
Ma ciò che fa davvero la differenza con la fiaba, con la quale spesso è confusa, è il contenuto: la favola non potrà mai prescindere da una morale o da un insegnamento, per velati o espliciti che siano: essi sono indispensabili alla conclusione e al senso della storia.
L’intento etico o educativo della favola fa sì che nasca come specchio riflettente del suo tempo, di cui condanna i vizi, fustiga la dissolutezza, disvela l’ipocrisia, lasciando allo stesso tempo trapelare una società ideale, o quantomeno quella che l’autore auspica.
La morale contenuta varierà nei secoli da cultura a cultura, destinata ad evolversi insieme alla società che rispecchia e che critica.
In questo senso possiamo affermare che la favola è sicuramente un racconto che sa di contemporaneità, e che è immersa nel suo tempo tanto quanto la fiaba è avulsa da ogni realtà.”
Tale è stata l’impronta che Esopo e Fedro hanno dato alla favola e su questi binari si è mossa nei secoli.
Le varianti sono state più o meno brillanti, ma l’intento pedagogico o la satira sociale sono stati gli elementi che le hanno permesso di cavalcare ogni evento, domandolo, senza mai soccombere.
Sorvolando i tempi antichi, per i quali vi rinvio ai primissimi articoli della rubrica
(https://culturalfemminile.com/2018/05/03/la-favola-dopo-esopo-di-mirella-morelli
https://culturalfemminile.com/2018/05/03/la-favola-dopo-esopo-di-mirella-morelli )
Ho proseguito il mio percorso prendendo in analisi alcuni autori molto famosi che si sono cimentati con questo genere letterario, ponendo così fine al luogo comune che vuole la favola come una scrittura di serie B.
In questo senso ho considerato “La favola del serpente verde e della bella Lilia”, in cui un Goethe nel pieno della fama si permette di sbeffeggiare l’ingessata società di fine Settecento in cui vive, scrivendo una favola assolutamente criptica, splendida ma piena simbolismi a posteriori definiti come massonici dai critici.
Secondo accreditate teorie egli, scrittore affermato, si serve di una piccola favola – ossia di un genere ritenuto sempliciotto o popolare o poco dotto, quando non puerile – per lanciare messaggi in codice, costruendo una storia di impalcatura complessa che solo i suoi amici massoni potevano comprendere, beffando tutti gli altri.
(https://culturalfemminile.com/2018/05/31/favola-di-johann-wolfgang-von-goethe/)
Il mio excursus si è soffermato quindi sulle favole di Andersen e sulla sua rivoluzione delle piccole cose: un autore nato povero, che deve la sua fortuna allo stile ma soprattutto al contenuto delle sue fiabe/favole: con lui abbiamo l’ingresso nei racconti di oggetti di uso comune e popolare quali forbici, colletti inamidati, e giocattoli semplici come soldatini di stagno, attuando un vero e proprio ribaltamento della morale comune.
Non necessariamente un re è felice solo perché re (come esplicitamente dimostra il racconto “Il guardiano di porci”).
Nelle sue favole prende avvio una società “democratica”, anche se il termine è ancora improprio, quasi a testimoniare l’anelito progressista ed avanzato che da sempre le favole rispetto alla società di riferimento.
(https://culturalfemminile.com/2018/09/02/andersen-e-la-favola/)
Ad Andersen ho affiancato il suo contemporaneo e conterraneo Kierkegaard: chi avrebbe mai detto che un filosofo potesse interessarsi alle favole?! Eppure è accaduto, come ho evidenziato nel quinto articolo della rubrica:
(https://culturalfemminile.com/2018/10/15/favole-di-soren-kierkegaard/).
Kierkegaard inserisce favole qua e là nei suoi scritti, con l’intento di contestare Andersen ma soprattutto di piegare la favola stessa al suo pensiero filosofico, divulgandolo.
In realtà egli è la dimostrazione che la favola, per essere efficace, deve si contenere un intento etico ma avere stile e linguaggio leggeri per essere comprensibili a tutti ed assolvere al loro enorme potere divulgativo.
Le brevi favole di Kierkegaard non offrono particolari critiche alla società in cui vive, ma nell’insieme biasimano i letterati e una certa cultura dell’epoca, consentendo a noi di cogliere l’interesse crescente che questo genere letterario suscita negli uomini colti, dopo essere stato per secoli appannaggio delle persone umili.
Siamo a fine Ottocento e ormai la favola non è più un genere di serie B, anche se sono ancora molti i pregiudizi nei suoi confronti.
La fine del Diciannovesimo secolo segna la nascita di grandissimi scrittori di favole, uno dei quali è Lewis Carroll, pseudonimo di Charles Lutwidge Dodgson (Daresbury, 27 gennaio 1832 – Guildford, 14 gennaio 1898).
E lui sì che affiderà a una favola, Alice nel Paese delle Meraviglie, la sottile ma feroce critica della società vittoriana in cui viveva.
Molte sono le chiavi di lettura di questo grande libro.
Alice in the Wonderland è difatti una favola piena di simbologia che nel corso del tempo è stata analizzata da un punto di vista letterario, sociologico ma soprattutto psicologico.
Sicuramente dai più è stata ricondotta a quest’ultimo approccio, affermando che Alice nel Paese delle Meraviglie è la metafora del rapporto conflittuale tra età infantile ed età adulta, una metafora del processo di apprendimento e di crescita.
Nella favola, la protagonista si confronta con una realtà in cui nome e regole sono capovolte: inseguendo il Bianconiglio precipita in una tana profonda – la qual cosa viene interpretata come una caduta nell’inconscio – divenendo una protagonista positiva, colei che abbandona il noioso pomeriggio al parco per inseguire l’incerto, l’ignoto, cedendo alla curiosità della scoperta e della conoscenza.
Alice difatti segue instancabile il Bianconiglio fin giù nel profondo della terra, che sta a simboleggiare la profondità del suo essere.
La sua è una caduta interminabile e lenta, come lenta e interminabile sembra essere il passaggio dall’età infantile all’età adulta.
Personaggio sfuggente e pieno di fretta, continuamente oberato di impegni, il Bianconiglio è stato interpretato dagli studiosi come simbolo dei genitori, stressati ma che a loro volta riempiono di stress i propri figli subissandoli di compiti e aspettative.
Il Brucaliffo è invece il personaggio che simboleggia la razionalità degli adulti, la loro cosiddetta saggezza o esperienza.
Egli non è accomodante con Alice – al contrario la bimba dovrà cercare ogni soluzione da sola.
In ogni caso, è il simbolo del mutamento e della crescita, tanto che alla fine del suo incontro con Alice si trasforma in una farfalla.
Altro importante personaggio simbolico è lo Stregatto, l’elemento porta-scompiglio della storia, colui che mette disordine, cioè scombina l’ordine prestabilito. Molti studiosi ritengono che simboleggi l’autore stesso, poiché lo Stregatto è colui che rivela ad Alice che in quel Paese delle Meraviglie sono tutti matti.
Anche la Regina di Cuori è un personaggio simbolico, da molti ritenuta la personificazione della rabbia degli adulti. Il metodo risoluto di tagliare la testa sta a rappresentare il modo in cui gli adulti tendono ad affrontare e risolvere i problemi.
Alice la affronta eroicamente e la sconfigge, e in questa sconfitta sta il simbolo della fiducia in se stessa, necessaria in ogni lotta dell’esistenza se si vuole arrivare alla vittoria – per Alice, crescere.
Ma l’episodio più famoso di Alice nel Paese delle Meraviglie è sicuramente quello del Cappellaio Matto e della Lepre Marzolina.
Tale episodio simboleggia il complesso rapporto tra Uomo e Tempo, nonché il desiderio di vivere nell’infinito, nel Tempo come divenire, nell’evento in quanto tale.
Durante il tè del Cappellaio Matto l’ora del tè si prolunga all’infinito, è costantemente tutto pronto e apparecchiato eppure il tè – che è sempre stato appena versato – non sarà mai bevuto.
L’attimo è sospeso, come in un fermo immagine.
E sta anche a simboleggiare l’incapacità di di vivere appieno: guai a fermarsi nel percorso evolutivo, guai a fermarsi nella ricerca di sé!
Aspetto affascinante e divertente della favola – anche se con un significato molto importante, di cui dirò a fine articolo – sono gli innumerevoli giochi di parole:
“Tu mangi tutto quello che vedi o vedi tutto quello che mangi?”
“Prendi più tè.”
“Non ne ho ancora preso niente, non posso prenderne di più.”
“Vuoi dire non puoi prenderne di meno. È facile prendere più di niente.”
“Non credere mai di essere altro che ciò che potrebbe sembrare ad altri che ciò che eri o avresti potuto essere non fosse altro che ciò che sei stata che sarebbe sembrato loro essere altro.”
Tutta questa simbologia è sicuramente interessante, così come l’intero approccio psicologico.
All’interno del nostro percorso, però, vorrei porre l’attenzione su un altro contenuto importante di Alice nel Paese delle Meraviglie: l’aspetto pedagogico.
Lewis Carroll visse nel cosiddetto periodo vittoriano. Giocoforza, questo periodo influenzò tanto i suoi scritti che i suoi personaggi.
Per epoca o età vittoriana si intende il periodo che va dal 1837 al 1901 e corrisponde al regno della Regina Vittoria.
Il libro “Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” è stato pubblicato nel 1865: siamo esattamente nel cuore del periodo!
In quel periodo i bambini benestanti, quale Alice sicuramente era, avevano a disposizione un maestro, o precettore, che li istruisse privatamente a casa.
I precettori dovevano fornire una buona preparazione di base su tutte le principali materie: geografia, storia, francese e altro. Alice stessa ce lo racconta più volte nel corso delle sue avventure.
I precettori imponevano ai loro allievi come metodo di studio la memorizzazione dei contenuti; il metodo mnemonico comportava che nel percorso di studi i bambini erano pieni di nozioni e vocaboli senza tuttavia neanche conoscerne il significato, o l’uso reale.
Poesie su poesie, rime su rime imparate a memoria tanto che, come ci racconta la stessa Alice, sa un sacco di cose senza sapere come applicarle.
Durante la sua avventura in Wonderland, Alice considera frequentemente che ciò che conosce a memoria non le è di nessun aiuto: dalle labbra di Alice escono parole diverse da quelle che vorrebbe dire, e Lewis Carroll si serve di questo stratagemma per foggiare alcune parodie tra le più ironiche che la letteratura conosca, alterando i versi più famosi che i piccoli allievi erano costretti a memorizzare per ritenersi istruiti.
I piccoli appartenenti a famiglie benestanti trascorrevano più tempo con precettori, domestici, fratelli e sorelle che non con i genitori. Il risultato qual è?
E’ che Alice nel corso delle sue avventure e difficoltà non nomina mai la madre o il padre. Al contrario, sappiamo che aveva una gatta di nome Dinah e due cuccioli, di cui ci dice nell’ultimo capitolo: Kitty e Snowdrop.
I genitori sono l’autorità, sono il mondo adulto distaccato e distante; per la risoluzione delle cose pratiche e dei piccoli problemi quotidiani ci sono i domestici, per l’affetto ci sono i cuccioli.
La critica all’educazione e alla famiglia vittoriana di Lewis Carroll è palese.
Allo stesso modo è palese la sua morale: i bambini hanno bisogno di presenza e non di distacco; la cultura non è fatta di apprendimento mnemonico, sterile, perché di fronte alle avversità dell’esistenza non ci verrà in soccorso in nessun modo.
Link all’acquisto:
Sinossi
“Si può leggere di primo acchito, senza pause, o comunque indifferenti alle interruzioni; poiché da qualsiasi punto si ricominci la lettura, è come riprendere la storia da un punto fermo, senza nessi da ricordare con quanto precede.
Ogni pagina è un inizio: per l’episodio che segue, per il personaggio che viene introdotto, per la situazione in cui Alice si trova. […]
L’invito al lettore è di seguire Alice nel suo viaggio fantasioso così come le piccole Liddell l’hanno seguito in barca, lungo il Tamigi, il 4 luglio del 1865.
Rinunciare a cercare troppo astrusi significati ha un grande effetto liberatorio; alla luce di quello che ancora una volta il saggio Re di Quadri sentenzia nell’ultimo capitolo:
‘Se non c’è nessun significato… questo, sapete, ci risparmia un mondo di guai, perché non abbiamo più bisogno di cercarne uno’.”
(dalla prefazione di Luigi Lunari)