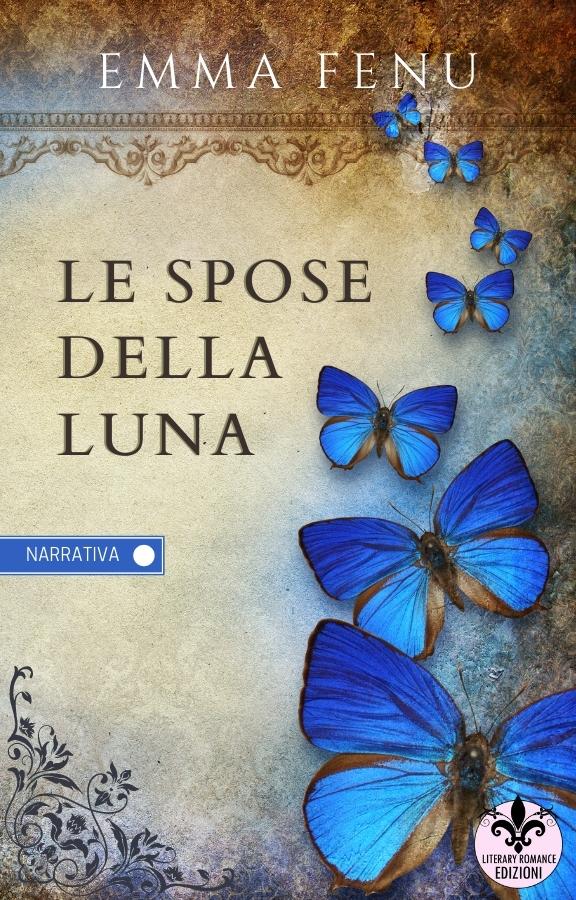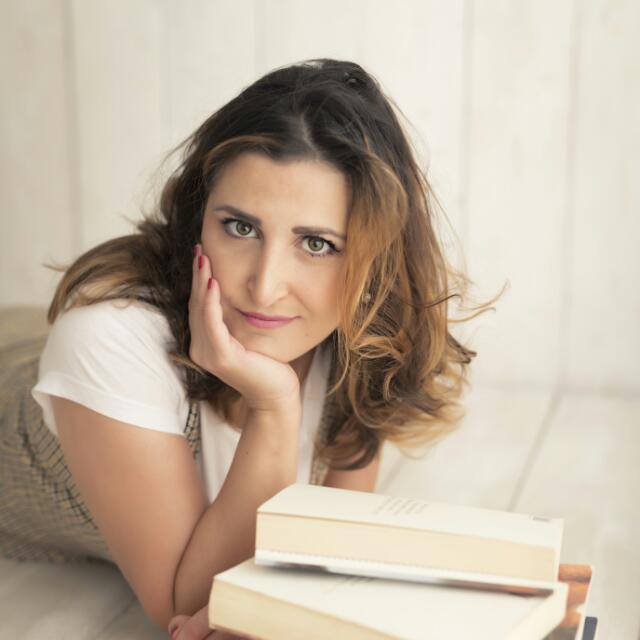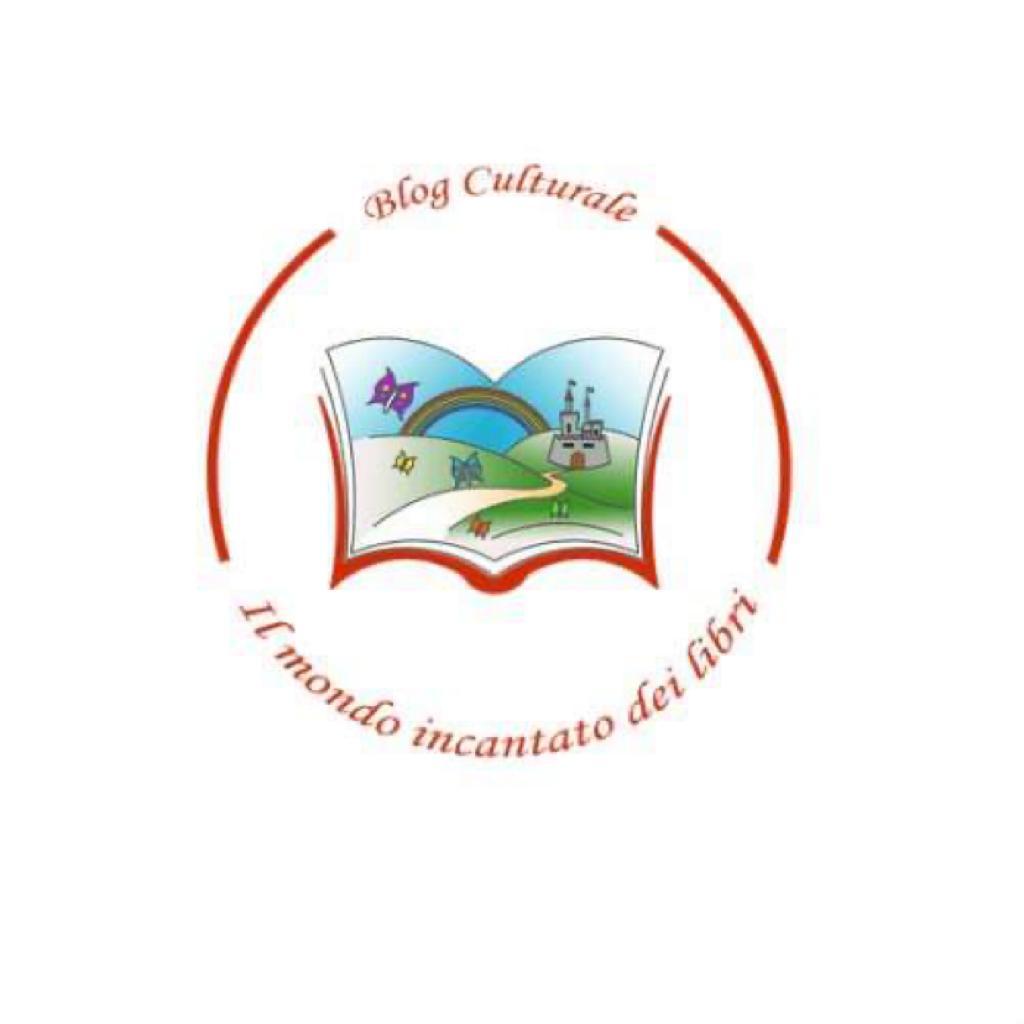La Pietra lunare di Tommaso Landolfi
di Paola Caramadre
E allora, d’improvviso, il giovane si sentì guardato. Dal fondo dell’oscurità, resa più cupa da un taglio alto di luce lunare sul muro di cinta, due occhi neri, dilatati e selvaggi, lo guardavano fissamente. […] In quella i due occhi cominciarono a muoversi, o piuttosto a ingrandire giacché procedevano direttamente verso Giovancarlo, e una forma a precisarsi dall’oscurità: un volto pallido, dei capelli bruni, un seno abbagliante scoperto a mezzo…
L’epifania della donna. L’apparizione di questa creatura remota innesca la narrazione. Il suo nome è Gurù ed è la protagonista del romanzo di Tommaso Landolfi, La pietra lunare, scritto a Pico, il paese natale dell’autore, tra il luglio e l’agosto 1937, e pubblicato a Firenze nel 1939.
La vicenda narrativa tributa un omaggio ai luoghi dell’infanzia, nei quali immerge la narrazione di un sortilegio, dell’ebbrezza di una stagione che incrocia i destini del protagonista con una creatura notturna, incomprensibile: la misteriosa Gurù. Il romanzo è ambientato alla fine degli anni ’30, eppure narra di un universo arcano, racchiuso tra le montagne, immutabile nelle tradizioni e nelle credenze.
“Il paese del P.” in cui è ambientato il romanzo è un luogo desolato, legato strenuamente a superate vecchiezze; angusti sono i vicoli del paese, più angusti gli orizzonti dei paesani, avversi ad ogni forma di evoluzione e di progresso.
Il giovane protagonista è il nobile rampollo di una importante famiglia locale, solitamente vive in città, conosce un altro mondo, vive un altro tempo; durante i periodi di vacanza il giovane torna al paese natale, con curiosità e sufficienza si lascia coinvolgere nelle sorpassate conversazioni, dense di acredine dei parenti rimasti appartati nel paese remoto.
L’arcano si mescola alla quotidianità
Fin dalle prime pagine, lo sguardo selvaggio dall’oscurità illumina il giovane e lo proietta in un mondo insospettato. È la metafora meravigliosa di una iniziazione erotica, ma non solo. Gurù è l’eccezionalità in un contesto immutabile. Gurù nella sua duplice natura di creatura esoterica e umana, è il nodo eversivo nel mondo a cui appartiene, ed è la memoria vivente della storia dell’uomo, delle tradizioni ancestrali, è l’incarnazione di antichi istinti.
Nel suo corpo flessuoso convivono le memorie di un passato mitico e di un presente alieno al suo contesto. In questa giovane donna tutto è attorniato da un alone di mistero e diffidenza. La sua origine è spaventosa, sembra venuta dal niente, ultima erede di una stirpe di delinquenti efferati, rinnova le passate vicende della sua gente con i suoi occhi neri, la pelle bianca e le antiche nenie incomprensibili che avvincono chi l’ascolta.
La natura ferina di Gurù
Tutto il romanzo si costruisce intorno alla passione che investe il giovane che incontra per la prima volta Gurù nella sua forma ferina. È avvinto dalla curiosità e dall’orrore, ma anche dal fascino e dalla bellezza della donna, che compare nella notte, irrompe con grazia nella vita quotidiana e banale di una famiglia locale:
“Gurù entra, donde vieni?”
“Dalla montagna” rispose soltanto la ragazza, con una voce soffice e un po’ rauca.
Il romanzo è impregnato di paesaggi notturni, evocazioni, esche premonitrici e presagi. Tutto converge a creare la suspense per la notte di plenilunio. I due giovani sono già amanti, Gurù assiste alle tempeste, spia il cielo e conduce nelle notti il suo giovane amico per i luoghi montani, attraverso scalate e paesaggi che possiedono una potente forza suggestiva, fino alla notte fatale.
È notte di luna piena, scroscia un temporale, Gurù si trasforma. Il suo corpo subisce un mutamento: le sue gambe si fanno zampe di capra. L’istante della metamorfosi non comunica orridezza, ma accresce il fascino della sua figura che assomiglia a Venere che emerge dal mare. Della trasformazione il giovane uomo ricorda:
La capra si lagnava, anche la donna prese a lagnarsi a sospirare a mugolare, ad ansare convulsamente come per voluttà; le loro membra i loro organi entravano in una comunione sempre più serrata. Una nebbiolina lunare avvolse le due forme.
La trasformazione della donna in demoniaca parvenza di donna capra sotto l’effetto della luna.
Il potere dell’archetipo donna-fata-drago
Il romanzo si rivela intarsiato di una complessa metaforizzazione delle immagini. La notte lunghissima in cui il giovane assiste alla metamorfosi immaginata della fanciulla è costruita su più piani e coinvolge molte immagini e molte scene. I personaggi che costellano la notte di plenilunio, riflettono una densa e intensa produzione metaforica che irrompe nel territorio delle note e familiari montagne circostanti il paese natio.
La donna appare agli occhi dell’uomo nella sua essenza svelata, mostrata nell’istante della trasformazione. La metamorfosi rappresenta l’attimo di massima coincidenza tra il corpo della donna e l’immagine della femminilità. Il mistero della vita si annida nelle forme indefinite della donna che si nasconde e seduce. Si mostra, a sorpresa, nella notte di plenilunio allo sguardo maschile. E in questo si può leggere il topos dell’uomo che tenta di scoprire la forma remota della creatura che gli appare eccezionale, per uno sfuggente motivo che lo seduce e lo avvince, per una strana alchimia che si sprigiona dal corpo stesso della donna.
L’immagine di Gurù che si trasforma nel folto della notte, nel denso di una tempesta, rimarca le metamorfosi mitologiche del corpo della donna amata in ibridi, che intrecciano la natura umana alla forma di creature animali o vegetali, collegando la natura femminile ad entità mostruose, come la donna-fata-drago Melusine. La scoperta della duplice natura di Gurù scatena una notte di tregenda nella quale Giovancarlo, seguendo la donna-capra, assiste ad eventi eccezionali che lo sgomentano, come la lotta che si reitera tra gli spiriti di antichi briganti.
Il mondo fantastico nel quale il protagonista si imbatte possiede una umana concretezza che rimanda sempre alla carne, al corpo, all’istinto, al mondo sensibile, a realtà tangibili. Gli spiriti sono fatti di carne, sono uomini vivi. Nel buio fitto della notte Giovancarlo segue, intorpidito e confuso, la sua donna e gli spiriti-briganti. Scopre attraverso Gurù un mondo di creature meravigliose, arcane, oniriche. Creature che sfidano le leggi del tempo, superano le norme dell’esistenza umana.
Gurù è la porta che immette il giovane in un regno di sogno, in una congiuntura spazio-temporale in cui tutto appare plausibile. Nella notte infinita, immobile, ininterrotta il giovane incontra le altre Gurù, un popolo di creature notturne: donne-capra, uomini-lupo, spiriti umanati di corpi insepolti, e, infine, l’immagine, archetipica, delle madri universali, l’allusione all’immagine della morte che lo sfiora.
Il ripudio della donna che sfida la cultura patriarcale
Al mattino tutto si conclude. Avviene la nuova definitiva trasformazione di Gurù. La curiosità sazia riporta nel giovane uomo la cognizione del tempo. La donna-capra, creatura da mondo delle meraviglie, si ritrasforma nella donna-Gurù, umile fanciulla, cucitrice di bianco.
Il giovane parte, si allontana dal paese. L’epilogo è triste nel suo riformulare la storia più vecchia del mondo: il giovane abbandona la donna, coprendosi dietro false menzogne. La metamorfosi di Gurù si esaurisce. La donna resta intrappolata, senza via di scampo nella vita che le appartiene. Resta tra i vicoli di un paese sonnolento a vagare e sognare, a cantare nenie invitanti, tacciata di stregoneria, additata da irrequiete dicerie locali:
tanto per cominciare Gurù doveva essere “lunare” (cioè sterile) […] è arcinoto che appunto tra le lunari Quell’Amico (cioè il demonio, l’Infando) recluta di preferenza i lupi mannari.
Il giovane ha scoperto la femminilità di Gurù. La sua perfetta forma di donna, non deturpata dalle estremità ferine, è la rappresentazione di una donna che si slaccia dalla convenzione. La donna-capra è la donna guidata dall’istinto che, nella prima notte, splendente del suo sguardo protervo, sfacciato e cristallino dice:
Era tanto che…Attraverso la notte ti chiamavo…non mi piace la luna essa mi fa soffrire.
L’aura della ragazza è arcana, sembra capace di sortilegi, il suo unico potere è, invece, il suo aspetto e la sua assoluta indipendenza dalle convenzioni sociali dettate dalla morale comune. La donna attrae l’uomo con la complicità della notte. Il romanzo riproduce, in chiave misterica, la comunione tra uomo e donna, l’incontro tra i due estremi che appaiono inconciliabili. Il maschile e il femminile come concetti astratti, che enucleano in questo romanzo fantastico la diade delle due nature.
La natura solare dell’uomo che parte, alla quale si contrappone la natura notturna, lunare della donna, che resta. In questa caratterizzazione del femminile Tommaso Landolfi sottende una oscura linea di contatto con la memoria, l’ancestrale legame con una primitiva percezione di tutte le cose, dello spazio e del tempo. Al femminile affida la conoscenza istintiva della natura, del fluire stesso della vita, della forza sotterranea che avvince e incatena l’uomo.
La donna-capra rappresenta la Calipso di Ulisse, la creatura misterica che abbaglia con il potere, temporaneo e fatuo, della seduzione in cui si riformula, ogni volta, il mistero dell’origine della vita.
La vicenda è conficcata nell’essenza ineluttabile della notte foriera di prodigi. Ecco la notte che profonde aspettative fin dalle prime scene narrate:
Avevano ormai oltrepassate le ultime case e sboccarono sui campi aperti. Qui finalmente la luna si scoprì in tutto il suo splendore. Era, quella sera, una luna remota alta nel cielo col suo piccolo corteggio di chiare stelle. Giovancarlo notò che era piena o quasi. Nella vasta marea della sua piena luce la strada maestra innanzi a loro, si svolgeva come una più intensa vena.
La luna è la forza d’attrattiva che ritorna anche in altri racconti e romanzi landolfiani. In questo suo romanzo gioca la carta dell’ambientazione lunare, intesa come arcana, misteriosa.
La luna, la notte e la femminilità
La donna appare come evento irripetibile nella sua assolutezza, antica quanto la notte. È creatura che affonda le radici in un immemorabile passato. Racchiude in sé la compresenza del tempo, la capacità di decifrare i simboli e i segni, il potere di essere simbolo e segno incarnato. La donna è la notte, è la luna, è il vento. E il vento è nelle parole di Gurù, la verania delle veranie, metafora e simbolo:
Il vento il vento! Esso scoppia all’improvviso come fruscio di torrente, scroscia come pioggia, e cessa d’un tratto. È un’ala immensa che è passata , di quell’uccello dove sarà il corpo e dove arriverà l’altra ala? E’ un sospiro mozzato. Sotto l’altra ala vivono di certo altri uomini altri animali altre pietre, passando così egli ci ricongiunge a loro un momento, ci dà notizie di loro, il presentimento d’altre gioie altre vite e altri dolori. Egli ci cova tutti un momento; così mi pare. Sulla soglia del camposanto fioriscono le rosaspine, anche là dovrai venire con me…
La donna nella coscienza che le viene dal profondo dell’istinto, conosce le antiche tradizioni. Illustra all’uomo, ignaro d’ogni cosa, gli abitanti del luogo, i poteri delle piante, i nomi dei luoghi, la magia della notte, l’ebbrezza del desiderio. Lo avvince con lo sguardo presagio d’ogni evento, lo guida nell’oscurità, lo protegge dai fulmini, dagli spiriti, dai pericoli.
La figura di Gurù incarna l’immagine dell’eterno femminino, rievoca il ruolo di Eva (prima donna, prima peccatrice, prima tentatrice, prima condannata). Instaura un intenso legame con le nature deteriori, in un continuo innalzamento e abbassamento della funzione della femminilità. La metamorfosi di Gurù si raddoppia nella tessitura del romanzo. La trasformazione tematica convive con l’ordito metaforico del testo.
Il canto di Gurù
Il canto di Gurù è riprodotto in forma di metafora:
Spesso la fanciulla cantava a bocca chiusa, […] simile alle spade degli antichi cavalieri, trapassava come senza ferire e dalla sorda piaga si levava poi segretamente, s’espandeva lievitava scoppiava il dolore; o una macabra gioia, gonfia e torta, quasi fiorita di verruche, spaventosa a colui medesimo che n’era vittima. Terrore e desiderio malinconia e allegrezza s’avvicendavano, stringendolo, nell’animo del ritardatario; una mostruosa flora, rossastra sanguigna pareva a lui gli si gonfiasse dentro con muto lividore.
Le parole, che Tommaso Landolfi dosa con sapiente maestria, giocano con l’evocazione dell’immagine attraverso il suono. Tutto converge ad amplificare la trasmissione dell’immagine fantastica che non è semplicemente accennata, ma riprodotta con l’intensità che si cristallizza nello sguardo. Le metafore allertano tutti i sensi costruendo, attraverso la lingua letteraria, il calco dell’immagine che si definisce. Landolfi utilizza un procedimento prezioso, intarsiato di sinestesie, solitamente estraneo alla prosa.
Il romanzo possiede una musicalità modulabile e una estensione linguistica notevole che permette all’autore di inserire nel testo preziosismi, arcaismi, espressioni dialettali e onomatopee che ampliano a dismisura la percezione del lettore. La forza della figura di Gurù consiste, forse, proprio nella riproduzione del suo linguaggio, che avvince nel continuo, incessante parlare. In un susseguirsi di domande e risposte, di narrazioni e di sospiri, interiezioni e immagini, suoni e canti.
Tommaso Landolfi e la sua scrittura
Tommaso Landolfi, nato a Pico il 9 agosto 1908 e morto a Ronciglione l’8 luglio 1979, è stato uno dei più originali e interessanti scrittori del ‘900 italiano. Rampollo di una famiglia di quella nobiltà terriera tipica del centrosud Italia, ha vissuto spostandosi tra Roma e le case da gioco più famose come quelle di Venezia e San Remo.
Attraverso il suo stile ha esplorato le più diverse forme narrative passando dal romanzo fantastico con “Cancroregina” per arrivare al romanzo gotico con “Racconto d’autunno” senza trascurare la fiaba e la poesia.
Profondo conoscitore della lingua e della letteratura russa è stato un apprezzato traduttore di Gogol’, Puškin, Turgenev e Dostoevskij. La sua vita letteraria si intreccia strettamente con il paese natale, piccolo borgo medievale tra i Monti Aurunci nel sud del Lazio. Lo scrittore, che ha esordito con la raccolta di racconti “Dialogo dei massimi sistemi”, ha sempre sottolineato di avere la necessità di soggiornare presso la casa paterna, nel “Paese del P.”, per poter scrivere. Il demone del gioco d’azzardo diventa anche un motivo letterario ne “La bière du pécheur” e “Rien va”.
Oggi il suo paese d’origine è entrato a far parte del circuito dei parchi letterari con il nome di “Tommaso Landolfi e il Paese del P.”