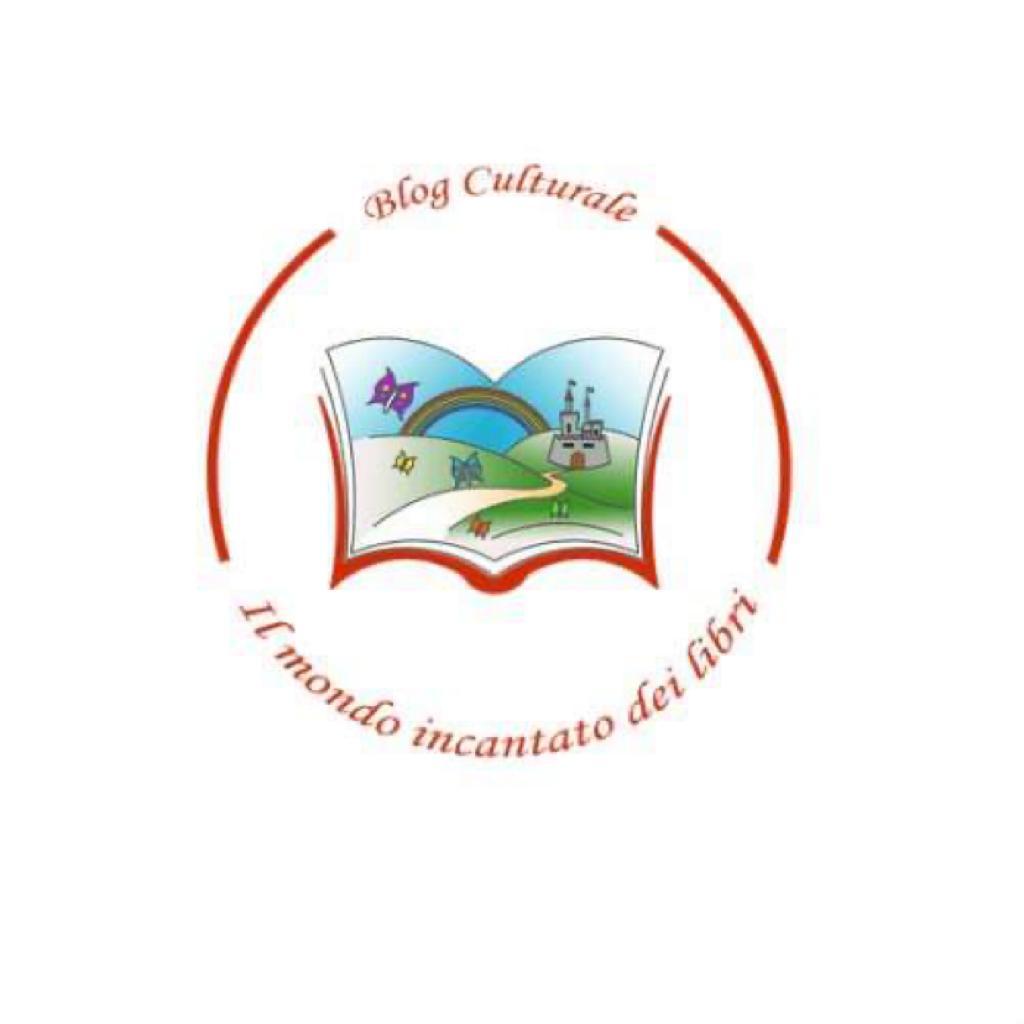Cammino svelta sul marciapiede d’asfalto. Sono partita presto, la città si sta svegliando, il sole filtra tra gli alti palazzi del centro. Varco veloce l’ingresso. La borsa sotto il metal detector, mentre la guardia mi scruta, svelta salgo le scale, mi guardo intorno e cerco di orientarmi. Sento il calore salire dal collo e prendo fiato. Ancora scale, il cuore batte forte, sto per arrivare.
Un lungo corridoio fitto di porte chiuse. Ecco, non è così che me lo immaginavo: niente grandi aule, niente posti a sedere per il pubblico, niente banchi degli imputati, né martelletti che ribattono il tempo.
Mi guardo intorno spaurita, il volto amico che aspetto ancora non c’è. Temo di incrociare per primo il nemico e… non ne ho voglia.
Questo siamo diventati: nemici.
Ecco, finalmente gli occhi amici e mi si allarga il sorriso, chissà perché a star sola è sempre peggio: che dipenda dalla mia insicurezza o stia dentro alla fatica di dovere fare la nemica?
Aspettiamo insieme il nostro turno. Soppesiamo gli ultimi fatti e mettiamo a punto i dettagli della strategia.
Abbiamo 15 minuti. Forse meno. Di quei 15 minuti speriamo di poterne usare almeno la metà, per essere equi e non sentirci prevaricati. Speriamo che quella metà basti a far pendere dalla nostra parte la ragione.
Perché di questo si tratta, fra nemici, in una mattina qualunque, davanti alla porta di una stanza anonima, ad attendere di essere chiamati: stabilire di chi sia la ragione.
Dentro quella piccola stanza siamo in cinque: i due nemici, i rispettivi avvocati e il giudice.
Chi fa causa a chi e per cosa.
Mentre leggono i fatti, interpretano motivazioni, pongono accuse e chiedono il conto, comprendo che questa donna, dagli occhi grandi e attenti, non potrà mai stabilire la ragione, in 15 minuti.
Qui dentro non esiste più la verità, esistono punti di vista, esiste l’orgoglio, il senso di ingiustizia. Esistono diritti e doveri.
I minuti scorrono mentre gli avvocati si beccano, alzano la voce, cercano di sovrastare e dire più forte dove stia una ragione che adesso mi sfugge.
Mi sento piccola e impotente, nelle mani e negli occhi di una donna che non immagino come possa comprendere davvero in che modo sia corsa la vita negli ultimi 10 anni. Come fa a sentire i risvegli e i sonni di tutti quei giorni? Come fa ad avvertire le sensazioni più brutte e le più belle di tutti quegli episodi elencati su quelle carte? Dieci anni radunati in alcuni miseri punti che ne raccontano il meglio e il peggio, dipende ancora dai punti di vista. Il guaio è che non combaciano. Non combaciano più.
Mi sento piccola e impotente perché nemmeno io so come fare a raccontare meglio quei 10 anni, in appena 7 minuti e mezzo, se va bene. Anni che non sono nemmeno i miei. Anni di cui sono stata spettatrice, comparsa, al massimo attrice non protagonista. Anni che sono i suoi, di lei.
Lei che qui non c’è.
Aspetta a casa di sapere che ne sarà di lei, dei suoi diritti e soprattutto quali siano i confini dei suoi doveri.
Lei che a 10 anni non ha più solo il diritto di crescere serena in mezzo a persone che la amano, ma ha scoperto di avere anche il dovere di farli contenti tutti, soddisfare le loro aspettative e confermare loro che sì, sono genitori meritevoli: lo vogliamo vedere riconosciuto nero su bianco, che così pare conti di più.
Lei che da adesso è il premio per il vincitore.
Lei che è l’unica a sapere davvero quale sia la verità: la verità è la sua, non la nostra. Quella che abbiamo interpretato, immaginato di comprendere, ritagliato in fotogrammi per dare piacere ai nostri occhi, al nostro orgoglio e al nostro cuore.
La sua combacia con la nostra? Non è importante che combaci, non importa che piaccia, non importa ascoltarla, almeno non in questa sede, riservata agli adulti e alla loro contesa dei figli.
Mi sento friggere su questa sedia mentre cerco di rimanere aderente a me stessa e alla promessa che le ho fatto:
Puoi fidarti di me. Porterò la tua verità. Non so se la ascolteranno. Non so quanto la interpreteranno. Non so se ci crederanno. Farò del mio meglio, te lo prometto.
La porta si chiude, sono finiti i minuti, non le parole.
Con lo stesso passo svelto ripercorro le scale fino in fondo, il cuore mi batte forte ancora. Ho fretta di uscire, riprendere l’auto e tornare a casa.
Incontrare quegli occhi spaventati e rassicurarli:
Ho fatto del mio meglio, non so come andrà, ma ci sono, sono qui e ho paura come te.
Dopo anni di corse lungo le scale ormai familiari, di ingressi in quella piccola stanza e di soste a 15 minuti per volta, la ragione, quella vera, si è persa del tutto.
Ci siamo imbattuti in diritti e doveri da rispettare. Siamo stati sezionati da più sguardi e giudicati dai diversi livelli di controllo: alcuni ci hanno ascoltato, altri ci hanno compreso, altri ancora hanno preferito interpretarci.
Ne siamo usciti tutti più ammaccati: consapevoli di quanto siamo impotenti di fronte alle maglie di una legge che si occupa di offrire un ordine sommario per le cose, ma non può ordinare come, quanto e quando volere bene.
Per volere davvero bene occorre lasciare stare la legge, senza arrendersi nella comunicazione: occorre la pazienza dell’amore.