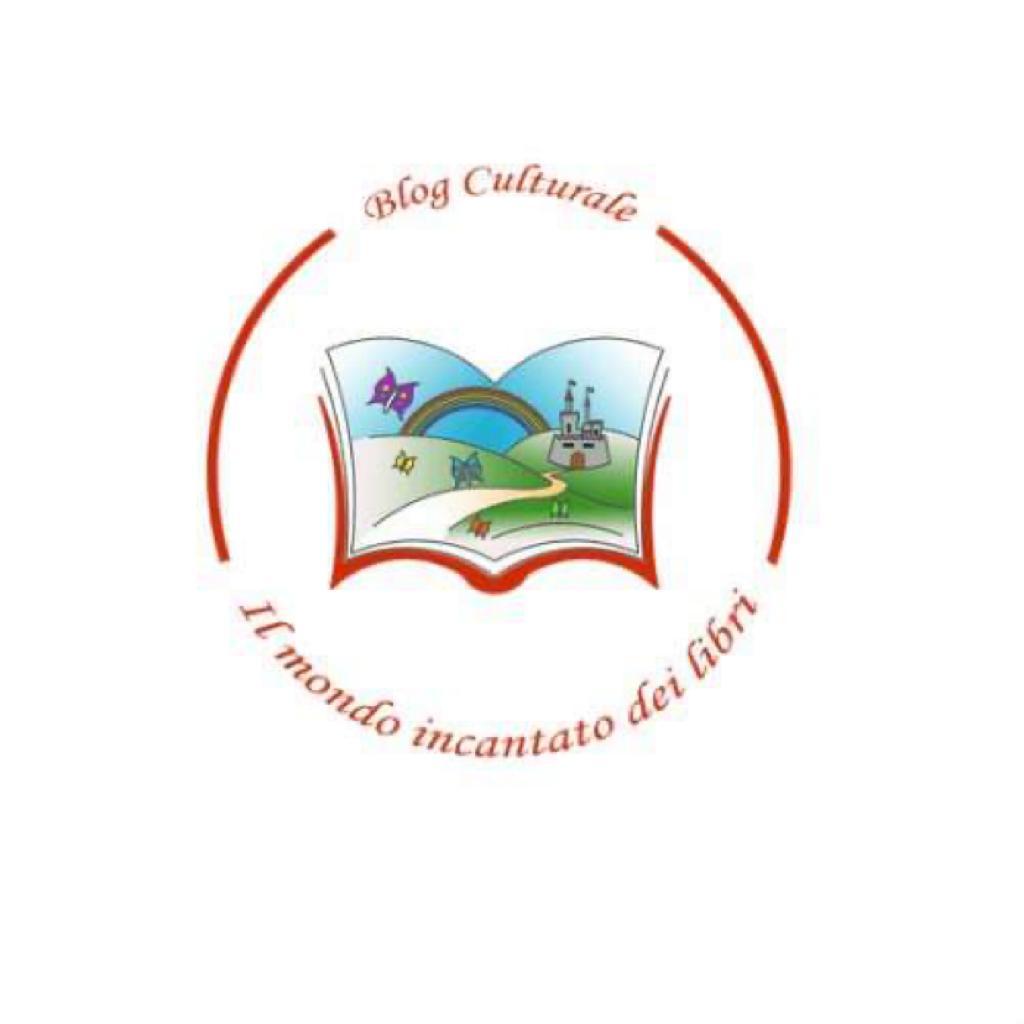“Qualche riflessione sullo haiku
e la poesia occidentale del Novecento”
di Ilaria Biondi
“Disegni sempre uguali e sempre diversi, traboccanti di vita acre e pura, […] giochi di schiuma che lascia dietro di sé l’onda che si ritira.”
(Yves Bonnefoy, Sull’haiku)[1]
La voga dell’orientalismo, che investe i paesi europei – la Francia in primis – tra la seconda metà dell’Ottocento e gli inizi del XX secolo, esercita non solo un impatto innovativo sulle arti visive, ma apporta anche un generale rafforzamento nella conoscenza della cultura giapponese.
In questo clima di apertura appassionata si inserisce la scoperta dello haiku, componimento poetico di cui si rintracciano testimonianze a partire dal V secolo d.C., ma che acquisisce forma autonoma nel XVII secolo, grazie a Matsuo Bashō.
“ Yuko Akita aveva due passioni. L’haiku. E la neve. L’haiku è un genere letterario giapponese. È una breve poesia di tre versi e diciassette sillabe. Non una di più.
La neve è una poesia. Una poesia che cade dalle nuvole in fiocchi bianchi e leggeri. Questa poesia arriva dalla labbra del cielo, dalla mano di Dio. Ha un nome. Un nome di un candore smagliante. Neve.”
(Da Neve, di Maxence Fermine)[2]
Il primo autore dell’Esagono a cimentarsi con lo haiku è Paul-Louis Couchoud.
Agli inizi del XIX secolo egli dà vita al movimento dello haikai francese e nel 1905 pubblica la plaquette anonima Au fil de l’eau (esitando tra le diciture hokku, haïku, haïkaï), cui segue, nel 1906, Epigrammes lyriques du Japon.
Couchoud ravvisa nella brevità, nella potenza suggestiva, nella sensazione lirica subitanea e priva di nessi logici, nell’assenza di spiegazione e di tono oratorio le precipue caratteristiche di questa forma poetica.
Per confortare la sua tesi, egli cita il linguista Basil Hall Chamberlain, che definisce lo haiku
“lucernario che si apre per un istante”,
“sospiro interrotto senza essere udito”.
Sulla sua scia nel 1920 Jean Paulhan pubblica un’antologia di haiku nelle pagine della «Nouvelle Revue Française».
Suo chiaro intento è di divulgare e radicare in Francia questo tipo di poesia, suscettibile di favorire un rinnovamento della produzione lirica autoctona.
Benché diversi nomi prendano parte a questa antologia,[3] che conosce una diffusione straordinaria negli anni Venti e nei decenni a seguire, è grazie alla presenza di Paulhan, Paul Eluard e Pierre-Albert Birot che lo haiku viene consacrato e legittimato in terra francese.
Pur senza conoscere il successo di forme tradizionali come il sonetto o il madrigale, lo haiku esercita tuttavia un’influenza decisiva sull’universo letterario del tempo.
Esso libera infatti il verso da costrizioni rigide come la rima e contribuisce al progressivo imporsi del verso libero.
Paul Eluard ripropone a più riprese in raccolte successive gli undici haiku pubblicati nella NRF, a indicare quanto egli si riconosca in questa forma poetica della brevità, della discontinuità, dell’intuizione (aliena alla speculazione razionale dell’Occidente),[4] della sensazione accolta e restituita sulla pagina, del linguaggio spoglio, di cui si ravvisano tracce e suggestioni in tutti i suoi poèmes courts.
“Le coeur à ce qu’elle chante
elle fait fondre la neige
la nourrice des oiseaux”
(P. Eluard)

Cent Phrases pour éventails (1927) è la raccolta con la quale un altro grande nome della poesia francese del Novecento, Paul Claudel, rende omaggio al Giappone, paese che nei suoi scritti viene rappresentato come un paradiso luminoso e glorioso.
Si tratta di una creazione originalissima nella quale Claudel, che durante i suoi soggiorni in Oriente apprende l’arte del pennello e dell’inchiostro a china, realizza un’opera calligrafica, una poesia ideogrammatica all’occidentale.
Egli non si limita pertanto a mutuare dagli haiku i canoni formali e il rapporto di continuità con la Natura, bensì riesce anche a penetrare lo spirito vivo e corporeo di questa forma poetica, che non è né cantata né scritta, ma “disegnata”.[5]
Paul-Louis Couchoud diventa il tramite attraverso il quale anche Rainer Maria Rilke, che soggiorna a lungo e a più riprese a Parigi, ove entra in contatto con il fermento artistico e letterario della capitale, si avvicina alla poetica dello haiku.
Il poeta austriaco, che soprattutto nell’ultima sua produzione anela (pur senza mai riuscirvi completamente) ad una progressiva riduzione dell’io, ad un distacco del soggetto poetante dalla realtà rappresentata, è profondamente affascinato dal modo di procedere, per semplice denominazione, dello haijin (il compositore di haiku).
Questi, nello spazio “miracoloso” delle 31 more, enuncia una percezione immediata, evidente, silenziosa, nell’assoluto di un istante, senza alcun fine speculativo né mediazione sentimentale, in uno stato di vuoto, di assenza dell’io, tradotto in un linguaggio snudato, asciugato, essenziale.
“Entre ses vingt fards
elle cherche un pot plein:
devenue pierre”
(R.M. Rilke)
Tra i poeti italiani che maggiormente subiscono il fascino della cultura nipponica e in particolare dello haiku[6] annoveriamo Edoardo Sanguineti, che volentieri ne adotta il rigido canone estetico, e soprattutto Andrea Zanzotto, sensibilissimo cantore del vivo fremere e palpitare della Natura che rimane folgorato dal verso saettante e privo di soggettività di questa forma poetica, capace di evocare con precisione e intensità eventi e aspetti del mondo naturale.
Zanzotto nel 2012 pubblica Haiku for a Season, una raccolta bilingue italiano – inglese originalissima, segnata dallo sperimentalismo e dalla ricerca di minimalismo linguistico (benché non sempre vengano rispettati i principi formali dello haiku e l’io del poeta riaffiori con una certa frequenza).
“Haiku of an unforseen day break
maybe mine – maybe bedrawls
or mini-noises of other universes”
“Haiku di un’alba inattesa
forse mia – forse cenni
o sussurri di altri universi”
(Andrea Zanzotto)

Come saggiamente afferma Yves Bonnefoy, uno dei più grandi poeti francesi contemporanei, scomparso di recente, oltre che critico lungimirante e raffinatissimo traduttore, l’Occidente ha riflettuto e fatto tesoro dalla prima metà del Novecento ad oggi su questa forma di poesia.
I poeti occidentali la riconoscono come
“riferimento necessario e fondamentale, che non può che restare al centro del [nostro] pensiero poetico […]”.[7]
Pur senza negare il valore e la qualità di tanta parte di questa produzione, Bonnefoy ci invita tuttavia a riconoscere la divergenza intrinseca tra la poesia occidentale e lo haiku, che sottendono differenti categorie di pensiero.
La prima è basata sulla riflessione concettuale e sulla speculazione, laddove il secondo è percezione immediata priva di concezioni soggettive e avulsa dal desiderio di analizzare.
Differente è anche il sistema sintattico, analitico quello occidentale, intuitivo quello giapponese.
Nello haiku non ci sono solo parole, ma caratteri che sono ideogrammi, pittogrammi, segni che conservano nella loro forma parte dell’aspetto delle cose (e lo haiku, essendo breve, permette di cogliere tutti i caratteri in un solo sguardo).
La scrittura occidentale invece si fonda sulla notazione alfabetica, che ha natura astratta e arbitraria.
La parola abolisce pertanto il rapporto immediato con il mondo, è separata dall’aspetto sensibile delle cose che nomina.
Il poeta occidentale inoltre ha una forte coscienza di sé, che persiste saldamente malgrado le lezioni d’impersonalità e di distacco che incontra in una poesia giapponese fortemente impregnata di buddhismo.[8]
Bonnefoy arriva persino a dire che la traduzione degli haiku non solo è ardua ma forse è finanche impossibile.
Eppure le traduzioni, benché impoverite per le ragioni appena esposte, rimangono la sola fonte di accesso a questa poesia e sono un esempio superbo di forma poetica breve, caratterizzata da profondità e limpidezza.
Al di là dunque delle intrinseche e ineliminabili divergenze, di cui è importante avere consapevolezza, rimane il fatto che lo haiku abbia rappresentato e rappresenti per l’Occidente una forma poetica ben precisa che scardina tradizioni “anchilosate” promuovendo un rinnovamento originale.
Ma esso è anche e soprattutto un’esperienza spirituale, che reca con sé un insegnamento e una saggezza di cui fare tesoro.
“Si spacca la brocca d’acqua
(Stanotte ha gelato)
Mi desta”
(Matsuo Bashō)
“Cos’è la poesia?” domandò il monaco.
“È un mistero ineffabile,” rispose Yuko.
Un mattino, il rumore della brocca dell’acqua che si spacca fa germogliare nella testa una goccia di poesia, risveglia l’animo e gli conferisce la sua bellezza. È il momento di dire l’indicibile. È il momento di viaggiare senza muoversi. È il momento di diventare poeti.
Non abbellire niente. Non parlare. Guardare e scrivere. Con poche parole. Diciassette sillabe. Uno haiku.
Un mattino, ci si sveglia. È il momento di ritirarsi dal mondo, per meglio sbalordirsene.
Un mattino, si prende il tempo per guardarsi vivere.”[9]

[1] Yves Bonnefoy, Sull’haiku, Milano, O barra O edizioni, 2015, cit. pag. 22. Traduzione del francese di Andrea Cocco
[2] Maxence Fermine, Neige, Milano, Bompiani, 1999, pag. 13. Traduzione dal francese di S. C. Perroni.
[3] Il genere suscita l’interesse anche di Paul Valéry, che non si misura con questa forma poetica, ma che nel 1924 cura la prefazione a una raccolta di haiku tradotti in francese di Kikou Yamata.
Marguerite Yourcenar dal canto suo, fortemente legata all’universo giapponese, non compone haiku, ma si interessa a lungo di Matsuo Bashō, riconoscendosi profondamente nel suo concetto di viaggio come esilio e come compimento della propria missione artistica.
La scrittrice ricalca le sue orme ripercorrendo il medesimo viaggio nel nord del Giappone a distanza di tre secoli, nel tentativo di entrare in contatto con la sua anima di poeta, esperienza che confluirà nella stesura dell’articolo Bashō sur la route.
[6] Alcuni studiosi fanno rientrare in questo novero anche D’Annunzio e Ungaretti, ma nel loro caso si tratta di un più generico legame con la cultura orientale, non già di un concreto cimentarsi con la forma poetica haiku.
[7] Yves Bonnefoy, op. cit., pag. 57.
[8] Bonnefoy lo ascrive per buona misura al Cristianesimo, secondo il quale la persona possiede una realtà in sé e un valore assoluto. Il poeta occidentale fatica pertanto a staccarsi da una riflessione su se stesso, ciò che gli impedisce di incontrare il reale nella sua unità, di dissolvere l’io nell’evidenza del mondo.
[9] M. Fermine, op. cit. pag. 16.