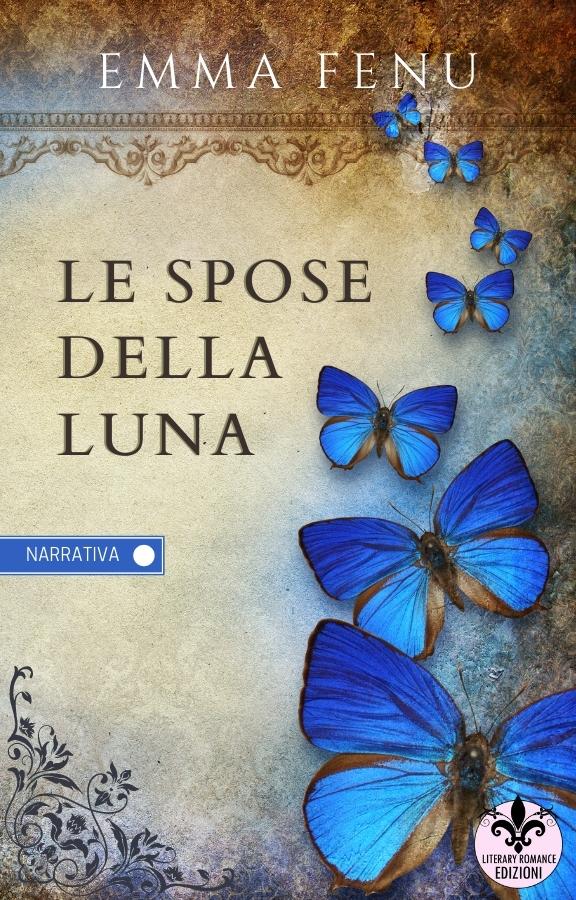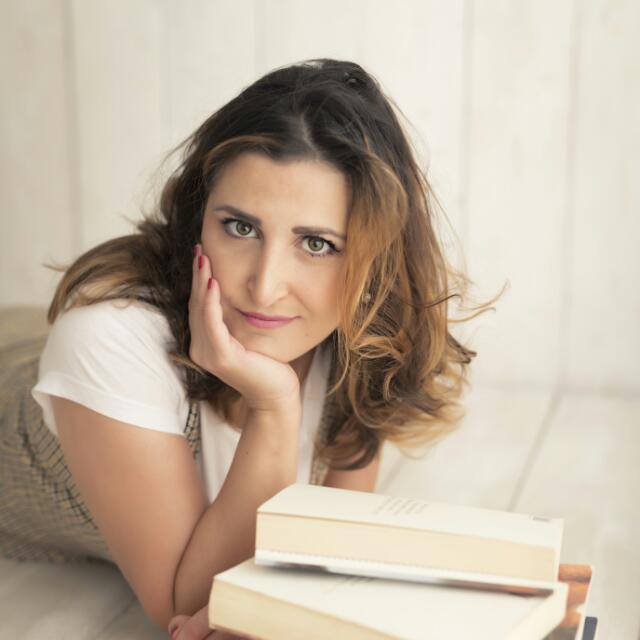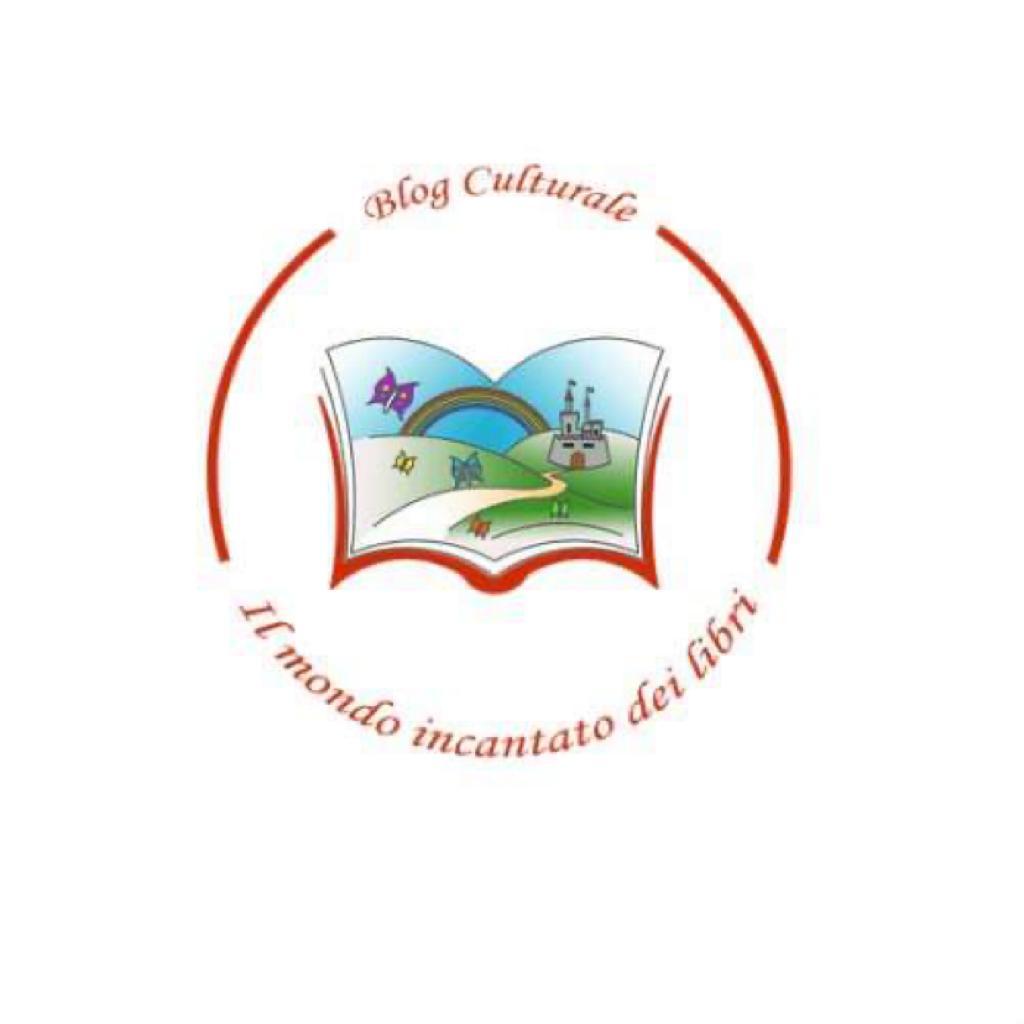ELISABETTA SIRANI – VIRTUOSA DEL PENNELLO
a cura di Paola Treu
Elisabetta Sirani (1638- 1665) è una delle più influenti e innovative pittrici della Scuola bolognese, dalla parabola breve ma intensa e luminosa.
Con quest’articolo, prosegue il mio lavoro di approfondimento di quelle figure di donne che riuscirono ad affermarsi nel campo artistico in Italia tra i secoli XVI e XVII.
Ho già dedicato diversi articoli a questo tema (“Le Signore dell’arte italiana tra XVI e XVI secolo”, “Sofonisba Anguissola: una pittrice alla corte del re”, “Lavinia Fontana, Pontificia Pittrice” e “Artemisia Gentileschi, il riscatto dell’arte”).
Elisabetta Sirani fu ritenuta dai suoi contemporanei “il miglior pennello di Bologna”, l’artista, fregiata anche del titolo di “maestra”, mise a punto uno stile elegante ed espressivo.
Dotta e prolifica pittrice, la più celebrata e quotata della città, era la figlia più famosa dell’affermato pittore e mercante d’arte bolognese Giovanni Andrea Sirani, che la iniziò al classicismo di Guido Reni, di cui era seguace e stretto collaboratore.
Giovane prodigio, molto colta, avida lettrice e brava musicista, Elisabetta presto matura una personale cifra stilistica, espressiva e intima, ovvero trova il modo di “far maniera da sé”, per dirla col suo biografo e mentore Carlo Cesare Malvasia.
Lavora ideando schizzi veloci, a cui seguiva la pronta esecuzione che non trascurava il minimo dettaglio dell’opera.
Le varie fasi della realizzazione del dipinto avvengono con una tale rapidità da poter assistere in breve tempo all’opera completa; il disegno dal quale prende forma il soggetto, la stesura dei colori e la grande padronanza del segno, le consentono di abbozzare e poi perfezionare l’opera senza tentennamenti né ripensamenti, dando forma a uno stile pulito, morbido e dai toni delicatissimi.
L’eccezionalità della Sirani risiede tuttavia nella creazione di una scuola d’arte per sole anciulle (l’Accademia del Disegno), la prima di questo genere e in cui studiano anche le sorelle minori Anna Maria e Barbara.
È un nuovo modello didattico, la cui particolarità consisteva nel fatto che l’istruzione del disegno e della pittura era impartita direttamente dall’artista come formatrice anziché dal padre, dal marito o da qualche fratello delle allieve.
La sua rivoluzione si attua dunque nell’essere una delle prime pittrici a fondare un istituto artistico professionale fuori le mura di un convento. Secondo il Malvasia annovera circa undici apprendiste bolognesi, che “seguono l’esempio di questa tanto degna pittrice”.
Formate direttamente da Elisabetta presso “la sua scuola” o influenzate dal suo esempio pionieristico, tutte queste fanciulle si diedero all’arte da professioniste riconosciute a Bologna e in tutta Italia.
Quindi, a Elisabetta Sirani spetta il merito di aver fornito un’alternativa radicale al modello dell’insegnante maschile consolidato nella pratica artistica, non più solo di appannaggio degli uomini, ma anche delle donne, dando vita a un esempio femminile di educazione artistica, e quindi della conoscenza e della diffusione della cultura.
Bologna, la più importante delle città pontificie dopo Roma, si dimostrò terreno fertile per simili sviluppi, forte di una tradizione umanistica segnata da docenti universitarie, scrittrici, editrici, ma anche pittrici e scultrici.
Non impiegò molto a diventare una pittrice conosciuta e apprezzata, ammirata da una committenza illustre e nobile (intellettuali, aristocratici, ecclesiastici e membri dell’élite politica di Bologna).
Oltre a dar prova di un’arte straordinariamente prolifica, Elisabetta non ebbe rivali nella rapidità esecutiva (“facilità”). “Era tale la velocità e la franchezza del suo pennello, ch’ella sembrava più leggiadramente scherzare che dipingere.” (O. Mazzoni Toselli, Racconti storici di Bologna ad illustrazione della storia patria, 1875).
“Io posso ben dire per verità,” dice il Malvasia, “essermi trovato presente più volte che venutole qualche commissione di quadro, presa ben tosto la matita, e giù postone speditamente in due segni su carta bianca il pensiero, (era questo il solito suo modo di disegnare da gran maestro appunto e da pochi praticato, e nemeno dal padre istesso) intinto piccolo pennello in acquarella d’inchiostro ne faceva apparire ben tosto la spiritosa invenzione, che si poteva dire senza segni dissegnata, ombrata, ed insieme lumeggiata tutto in un tempo
[…] Tant’era la prontezza nello immaginare la composizione de’ quadri, tanta la sicurezza nell’eseguirla che l’aspetto delle illustri persone che andavano a vederla dipingere, anziché intimidirla l’incoraggiava.” (Carlo Cesare Malvasia, Felsinea pittrice. Vita de’ pittori bolognesi, 1678).
La sua sorprendente velocità d’esecuzione le permise di realizzare circa duecento tele, quindici incisioni e innumerevoli disegni e schizzi ad acquerello nell’arco di una carriera durata poco più di un decennio (1654-1665).
Ad ogni modo, questa rapidità fu giudicata da molti sospetta. Per fugare ogni dubbio e dimostrare l’autenticità della sua opera, concesse al pubblico, che a poco a poco giunge da tutta Europa, di assistere alle sue sedute di pittura nel proprio studio, in via Urbana 7,
dove “lavorava dall’alba al tramonto, tutti i giorni eccetto la domenica, e trovava anche il tempo per intrattenere gli ospiti con conversazioni spiritose e buona musica.” (Germaine McGreer in Le tele di Penelope, le donne e la pittura attraverso i secoli”, 1980).
Inoltre, teneva un registro delle sue pitture sotto forma di diario di lavoro – Nota delle pitture fatto da me Elisabetta Sirani, iniziato nel 1655 e successivamente pubblicato dal Malvasia nella sua Felsinea Pittrice. È un documento di estrema importanza perché permette di ricostruire l’ampiezza e la portata della sua produzione nonché la rete dei suoi clienti e mecenati.
I suoi lavori erano richiesti anche da sovrani e capi della diplomazia di tutta Italia e d’Europa, come i Medici e i Re di Polonia, motivo per cui alcune sue opere si conservano nelle principali collezioni europee già durante la sua breve vita.
Prova certa del successo professionale conseguito da Elisabetta fu l’ammissione all’Accademia di San Luca a Roma, anche se in quanto donna non poteva assistere alle riunioni (Statuto del 1607).
Nel 1662 la Sirani fu costretta ad assumere la direzione della bottega del padre, ammalatosi gravemente, senza però abbandonare la docenza presso il suo istituto d’arte.
Acquisì il ruolo di “Capomaestra” che, oltre a garantirle un ampio grado di autonomia, le diede la responsabilità di mantenere economicamente la propria famiglia e gli apprendisti e gli assistenti della bottega. (“La figliola la quale in oggi qui è ritenuta maestra et è lei che mantiene con sui lavori tutta la numerosa famiglia.” Malvasia, Felsinea Pittrice, cit.).
Per una donna dell’epoca, si trattava di una situazione del tutto eccezionale, la società riconosceva infatti ai soli uomini la dignità di capofamiglia e responsabili del sostentamento materiale.
La sua affermazione professionale e il consenso critico le derivarono dalla speciale ideazione di un repertorio originale nella rappresentazione di eroine tratte dalla Bibbia e dalla storia classica (Istoria), fatto particolarmente insolito dato che alle donne era vietato praticare il disegno dal vero.
Si tratta delle cosiddette femmes fortes, figure femminili forti, coraggiose e intelligenti, come Giuditta, Dalila, Circe, Cleopatra e diverse altre). In questi dipinti storici, Elisabetta Sirani diede vita a raffigurazioni iconiche di donne che, col loro piglio indomito e volitivo, vantano le virtù positive dell’acume, dell’ardimento e del valore trionfante.
Il modo innovativo in cui Elisabetta interpreta queste eroine venne definito maschile: Malvasia dichiarò che il suo stile “ebbe del virile e del grande”, mentre padre Bonaventura di Bisi scrisse che “dipinge da homo con molta prontezza et invenzione.” (Lettera a Leopoldo de’ Medici del 22 gennaio 1658).
Particolarmente apprezzata era la sua tecnica, caratterizzata da un’ampia pennellata e da un impasto fluido abbinato a un ricco colorito di impronta veneta e profondi chiaroscuri.
Si dedicò anche ai ritratti allegorici e di rappresentanza e ai quadri di uso devozionale, con scene meravigliosamente rese della Sacra Famiglia, dei Santi ma soprattutto della Madonna col Bambino, suo punto di forza, in cui lo scambio emotivo tra madre e figlio è intriso di dolcezza e intimità.
Come ulteriore conferma della sua indipendenza raggiunta sul piano professionale e sociale, sigla le proprie opere, in un’epoca contraddistinta dalla scarsa rilevanza giuridica della firma apposta dalle donne. Ritroviamo così il suo nome sui bottoni, sulle scollature, sui merletti, sulle fasce d’abito o ancora sugli elementi architettonici.
L’attività instancabile e quasi febbrile è la principale causa della malattia che portò l’artista a una morte precoce dovuta a una grave ulcera gastrica, all’età di soli ventisette anni.
I funerali di Elisabetta, “la pittrice eroina”, “il prodigio dell’arte, la gloria del sesso donnesco, la gemma di Italia, il sole d’Europa” (Malvasia) furono “lacrimosi e solenni come quelli d’una santa papessa” (Malvasia) e venne seppellita accanto alla tomba di Guido Reni nella cappella del Rosario della chiesa di San Domenico a Bologna.
La fama di Elisabetta Sirani risplende perché fu un’eccellente professionista, che intraprese un percorso artistico importante e significativo, capace di rendersi protagonista del secolo d’oro della pittura bolognese.
Seppe farsi strada nel proprio campo, grazie alla tenacia e al talento, nonostante le dure limitazioni che l’epoca imponeva alle donne.