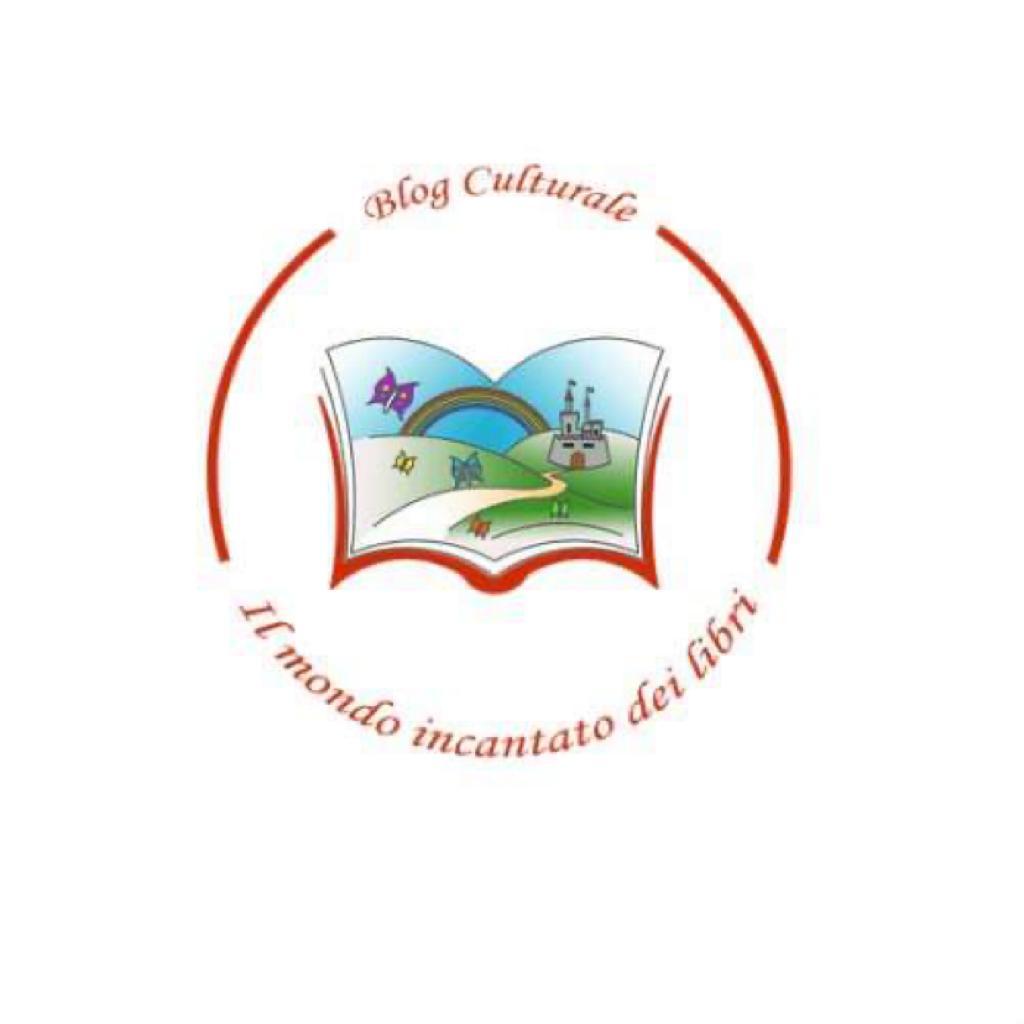Altra acqua, per favore –
di Silvia Bodini
È la prima domenica del mese e non ne sono felice.
Mi siedo a tavola e fisso il piatto per cinque minuti.
A qualcuno potrebbe sembrare strano, ma qui, alla St. Mary Clinic di Boston, è la routine.
Mi scolo, tutto d’un sorso, il bicchiere che un inserviente aveva riempito d’acqua poco prima.
Sono Charlotte, ho ventitre anni e soffro di anoressia nervosa da quando ne ho tredici.
Sedute al mio stesso tavolo altre nove ragazze: c’è chi come me contempla il piatto, chi sta dividendo il cibo in tanti piccoli bocconcini, chi sta pianificando i modi più assurdi per scappare a vomitarlo senza farsi notare.
Verso altra acqua nel bicchiere.
Negli ultimi quattro anni ho iniziato percorsi di recupero in diverse cliniche, senza portarne a termine nessuno. Ho acquisito, però, diverse consapevolezze, in primis quella di essere malata. Scontato? Forse per voi sì, ma per un’anoressica non lo è.
Non si guarisce dall’anoressia fino a che non si capisce che è una malattia.
Purtroppo, però, ho ancora molta strada davanti a me. Per esempio, vorrei tanto poter dire che in questa clinica un giorno vale l’altro, ma non ci riesco.
Oggi è la prima domenica del mese, l’unico giorno in cui sono ammesse visite.
Bevo un sorso d’acqua.
Oggi, rivedo mia madre.
Oggi, dopo ventisette giorni di lavoro intenso e persino qualche miglioramento nel mio rapporto con il cibo, quel piatto di pasta al pomodoro torna ad essere, ai miei occhi, un ammasso di calorie.
Finisco tutta l’acqua nel bicchiere.
È il secondo, in meno di cinque minuti.
Lo allontano, devo smetterla, le regole sono chiare: non più di tre bicchieri d’acqua per pasto.
Mia madre è la sorgente della malattia da cui non riesco a guarire, lo sappiamo entrambe.
Non lo sapeva, però, quando da ventiduenne sola e vulnerabile, iniziò a frequentare un fotografo, molto più grande di lei. Lui mi aveva vista, ed era rimasto folgorato dai miei tratti particolari. «Questa bambina farà strada, se la saprai seguire bene» le disse.
Così mi iscrisse al mio primo concorso di bellezza.
Avevo cinque anni, volevo giocare con le bambole, ma la bambola divenni io.
Le prime volte sembrò un gioco, ma poi arrivarono le ciglia finte che bruciavano, l’arricciacapelli che scottava la cute e la situazione le sfuggì di mano.
Ricordo, nei camerini, i pianti delle altre bambine che mi facevano venire un gran mal di testa, ma quel che è peggio ricordo la delusione sul volto di mia madre quando tornavo a casa senza alcuna fascia.
Per i primi casting, poi, iniziai a saltare le lezioni di pianoforte a cui tenevo così tanto.
Non partecipavo più alle feste di compleanno delle mie amichette e quando ci riuscivo una frase rimbombava costante: «No, per Charlotte una fetta più piccola, grazie. Abbiamo un casting domani».
Mamma, vorrei una fetta come tutti gli altri, avrei voluto dirle.
Eppure, a otto anni mi assumevo, non solo il peso di una vita che non avrei voluto, ma anche la responsabilità di vedere mia madre felice.
La mia pelle color caffelatte era tutto ciò che le era rimasto dell’amore di un uomo troppo diverso da lei.
Il contrasto con i miei occhi azzurro ghiaccio, invece, l’orgoglio di poter dire: «Mia figlia è bellissima, così bella che lascerà il segno».
Riguardo il piatto di pasta, il pollo e le zucchine nel piatto e non vedo cibo, ma numeri.
Sono mille e cento le calorie che sto per mangiare.
Oggi è domenica e ci sarà anche il budino al cioccolato. Altre duecento calorie.
Vorrei alzarmi, correre nella mia camera, saltare il pasto. So che non posso.
Ed ecco, così, che tornano a fare eco nella mia mente tutte quelle parole che mi hanno portata ad essere qui ora, in questa clinica, a disprezzare il mio corpo e me stessa.
«Signora, sua figlia è bellissima, ma non sorride mai in camera. Non è adatta per questo spot».
Vedi, mamma? Te lo dicevano pure, perchè non hai saputo capire?
«Devi essere costante con la palestra, tesoro. Sai che ai miei occhi sei perfetta così, ma se vuoi passare le selezioni che stiamo aspettando da una vita devi buttare giù quei due chili!»
Tu le aspettavi mamma, non io.
E ancora: «Quel ragazzo non va bene per te, ti sta distraendo troppo… è un momento importante, non rovinarti la carriera».
Mamma, io, quella volta, mi ero innamorata.
Bevo un altro bicchiere d’acqua, il terzo, l’ultimo per questo pasto.
«Amore, stai dimagrendo troppo. Come mai? Sei stressata? Sei sempre in palestra, forse fai troppo cardio. Dovresti iniziare a fare un po’ di pesi, sai ora c’è questa tendenza del sodo; troppo magro non piace più».
Sì, mamma, era il cardio, eri tu, erano i tuoi sogni. Ero io, sempre troppo. Troppo triste, troppo felice, troppo grassa, troppo magra.
L’acqua sul tavolo è finita, cerco con lo sguardo un inserviente e chiedo: «Altra acqua, per favore».
L’infermiera nei paraggi intercetta la mia crisi: «Non hai ancora toccato cibo, Charlotte. Forza, provaci, le ultime settimane sono andate benissimo».
Voglio piangere, voglio altra acqua. Mi serve altra acqua.
Mamma, mi dispiace, non ho lasciato nessun segno nel mondo. In compenso, quello che tu hai lasciato a me non se ne va.